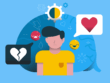Il tema di cui ci occuperemo oggi è oggetto di interesse quasi quotidiano. Si può affermare che non passa giorno senza che qualche episodio di cronaca ci riporti di fronte alla realtà di uomini che fanno violenza o uccidono le donne.
Il problema della violenza sulle donne è molto vasto e riguarda l’abuso sessuale nelle scuole, le molestie sessuali sul lavoro, gli stupri, le violenze nei campi profughi o gli abusi sessuali come tattica di guerra tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2006 ha dato l’avvio alla campagna globale per la prevenzione della violenza sancendo il principio che la violenza contro le donne è, in tutto il mondo, un problema primario di salute pubblica che deve essere prevenuto e curato.

Ciò che appare chiaro in queste forme di violenza è che esse sono la conseguenza di una mentalità di matrice patriarcale che tenta di perpetuare la subordinazione della donne e di annientarne l’identità, fino a provocarne la morte. Alla base c’è una condizione maschile, o maschilista, fintamente virile, che assume la forma del possesso, della sopraffazione, del concetto di onore tradito e di tutte le forme che, al contrario di quanto sembri, possono assumere le paure dell’uomo di fronte alla donna. Questi atti vengono posti in essere allo scopo di ottenere dalla donna un comportamento che risponda ad aspettative la vorrebbero riconosciuta esclusivamente in funzione del ruolo di madre, moglie, figlia, oggetto sessuale.
Il fenomeno non è localistico, visto che si riscontra in tutto il mondo; non è legato sostanzialmente all’età, gli uomini fanno violenza alle donne qualsiasi età abbiano loro e qualsiasi età abbiano le loro vittime, anche nella tarda adolescenza o nella vecchiaia, senza contare gli stupri di gruppo che a volte esitano nell’uccisione della vittima e che vengono compiuti spesso da preadolescenti; né può essere considerato espressione di una particolare cultura, proprio per la sua diffusione planetaria.
Per quanto riguarda l’Italia, le cifre riportate nel rapporto Istat del 2007 sono, in questo senso, impressionanti: 6 milioni e settecentomila donne tra i 16 e i 70 anni, almeno una volta nella vita, sono state vittime di violenza. Un numero che è pari al 32% della popolazione femminile, oltre nove milioni di donne. Inoltre solo il 6% delle violenze è opera di sconosciuti, il resto dei maltrattanti sono partner o ex partner e il 93% delle violenze perpetrate dal coniuge o dall’ex non viene denunciato.
Dati che allarmano perché una comunità dove la percentuale di violenza è così alta, è una comunità malata. Gente che vive per anni nell’odio, nel disprezzo e nella sofferenza, che litiga tutti i giorni, urla, umilia, ferisce.
Oggi ci soffermeremo però su quel 94% di violenze operate dal partner o dall’ex partner, e in particolare sul femminicidio, neologismo che viene usato per indicare tutti quei casi di omicidio in cui una donna viene uccisa da un uomo per motivi relativi alla sua identità di genere, quindi sull’assassinio di donne da parte di uomini che hanno avuto o hanno ancora legami strettamente sentimentali con la vittima. Il termine venne coniato nel 1993 a seguito dei fatti accaduti nella città messicana di Ciudad Juarez, città al confine tra Messico e Stati Uniti dove dal 1992 sono scomparse 4500 donne e 650 sono state stuprate, torturate, uccise e poi abbandonate o sotterrate nel deserto.
Mentre nei paesi occidentali il numero degli omicidi in generale è in costante declino, l’indice di quello dei femminicidi è in aumento, pur se con delle oscillazioni e delle stagnazioni nei vari anni considerati. In ogni caso nel mondo la prima causa di uccisione delle donne tra i 16 e i 44 anni è l’omicidio da parte di persone conosciute.
Spesso nei resoconti giornalistici di questi episodi l’accento viene messo sull’ovvia “colpa” dell’uomo, sul suo desiderio di possesso. Ci si riferisce alle cause sociologiche, culturali, all’accresciuta autonomia e indipendenza delle donne, alla conseguente maggiore fragilità dell’uomo. Ed è evidente che l’aumento del numero delle violenze nel mondo occidentale è in diretta connessione con le conquiste sociali e personali delle donne e con la conseguente accresciuta importanza del loro ruolo nella società.
Fattori tutti che hanno la loro rilevanza, considerato inoltre che in Italia abbiamo alle spalle un mondo patriarcale e un codice penale che giudicavano con molta indulgenza, quando non con simpatia, gli uomini che ammazzavano le “loro” donne per “onore”. Ma se è certo che sono gli uomini ad uccidere le donne è anche certo che non tutti lo fanno, pur condividendo tutti lo stesso ambiente sociale e culturale. Deve esserci qualcosa di specifico che accomuna questi uomini nella violenza, che li caratterizza e caratterizza i rapporti con le loro compagne. Qualcosa che è solo loro, che è nella loro storia e nella loro testa. Che li rende capaci, quando si trovano in situazioni da loro giudicate senza via d’uscita, di arrivare ad uccidere anche con una violenza estrema, con una ferocia inspiegabile. A volte rivolgono la violenza anche contro i figli, o uccidono davanti a loro, come se la punizione inflitta alle compagne non bastasse mai, come se la violenza fosse alimentata da una rabbia infinita.
Inoltre la maggioranza degli omicidi sono commessi da recidivi, cioè da uomini che non erano al primo episodio di violenza, quindi non si può parlare di episodio sporadico, di raptus.
Un altro fatto è soprattutto inquietante: perché spesso gli uomini dopo aver ucciso si uccidono a loro volta? Cosa accade loro che li fa sentire così disperati dopo una separazione o una minaccia di abbandono? Infatti quello che colpisce di più nel femminicidio è proprio che esso è portato a termine quasi regolarmente quando una donna minaccia di lasciare o lascia il compagno. E’ evidente che la gelosia maschile, il senso del possesso dell’oggetto amato, sono molto diversi da quelli femminili: noi uomini intuiamo e temiamo una superiorità, un’autonomia femminile, anche una disposizione al piacere che nessuna presunzione amorosa può del tutto addomesticare. Lo sapevano gli antichi, che avevano ridotto le donne in cattività, relegandole nel ruolo che più accontentava l’uomo.
Quando ci si avvicina al tema della violenza domestica, ci si trova di fronte a questa presunta passività femminile, ci si trova di fronte alla domanda: “perché le donne subiscono?”. Perché è noto che spesso gli esiti fatali sono conseguenti ad una lunga serie di violenze che si sono perpetrate per anni, spesso viene raccontato che le donne hanno sopportato, coperto, giustificato (quando addirittura non si sono sentite valorizzate dai segni di violenza sui loro corpi come simboli d’amore). Inevitabilmente se ci si pongono delle domande in questo senso, affiora il rischio di biasimare la vittima, come se cercare di capire significasse colpevolizzare la donna per giustificare l’uomo. Eppure porsi delle domande è obbligatorio se si vuole cercare di intravedere una qualche motivazione che dia una ragione di questa terribile e triste vicenda degli uomini che uccidono le donne: qual è la possibile dinamica che avvince vittima e carnefice? Perché a volte possono delinearsi percorsi così diversi e paralleli che conducono ad un tale senso di estraneità e sofferenza che l’altro se non può essere posseduto, nel senso più lato del termine, deve essere eliminato?
Come al solito in psicoanalisi, cominciamo dal principio.
La soggettivazione
Dunque per tutti esiste nel corso dello sviluppo il vincolarsi della libido, che è la forza vitale che contiene in sé tutti gli impulsi, ad una persona in particolare, che chiamiamo l’oggetto primario e che è chi fornisce le cure, il caregiver, oggetto primario che in genere è la madre.
I rapporti con la madre, nei primi tempi dello sviluppo, sono rapporti essenzialmente narcisistici: non essendoci ancora separazione tra Io e mondo, tra Me e non-Me, il rapporto con l’oggetto esterno, è ancora solo rapporto con il proprio Sé, tanto che la scoperta di ciò che sta al di fuori è il primo atto di individuazione, in quanto il bambino comincia a pensare a se stesso come a qualcosa di separato.
Quindi, nelle normali condizioni di sviluppo arrivare a concepire la madre come un oggetto esterno separato, rappresenta il primo atto verso la individuazione, fatto che comporta la perdita del rapporto con l’oggetto come parte del Sé, per riconoscerlo come oggetto staccato, autonomo.
Ma se a causa di una mortificazione reale, di una delusione, di una difficoltà di rapporto con questa figura, la relazione viene disturbata, allora essa non evolve naturalmente verso un processo di individuazione e di separazione perché, allo scopo di evitare la perdita dell’oggetto amato, anzi per trattenere ancora l’ oggetto con il quale il legame è diventato labile e insicuro, l’Io stacca la libido ad esso collegata, ma anziché spostarla su un’altra persona la riporta all’interno di se stesso: l’Io torna ad amare se stesso perché l’oggetto verso cui si era riversato l’amore non si è dimostrato affidabile.
Questo ritiro serve a sottrarre dalla dissoluzione l’amore verso l’oggetto, cioè l’Io salva l’amore, visto che non può salvare l’oggetto. Ma questo meccanismo di introiezione rende impossibile un compiuto processo di separazione perché se l’oggetto è introiettato, logicamente il distacco dall’oggetto diviene impossibile. Si resta, in altri termini, in una condizione di pre-individuazione, pre-soggettivazione.
La mia semplificazione non deve lasciar intendere che questo sia l’esito di una situazione sporadica, occasionale. Non si può pensare, in altri termini, alla delusione di una volta, due, dieci. La mancata soggettivazione è la conseguenza di un tipo di rapporto costante con la madre, che dura per tutto il periodo dell’accudimento, così mentre le accresciute capacità fisiologiche conducono all’autonomia fisica, le capacità psicologiche non si rendono autonome allo stesso modo. Non si raggiunge cioè quello stadio di sviluppo che Winnicott definisce “separatezza” e che consiste nella capacità di essere soli. E’ fondamentale accedere a questa capacità, perché solo se sappiamo essere soli riusciamo a bastarci, a essere autosufficienti, autonomi e, cosa che può apparire paradossale ma che è la conseguenza più importante del processo, a non sentirsi soli.
Questa condizione ci si impone come uno stampo. Il futuro della nostra vita affettiva sarà caratterizzato da quanto è accaduto in queste primissime relazioni. Nell’incontro con l’Altro del futuro riproporremo sempre modalità di rapporto di tipo fusionale, modalità nelle quali, per sfuggire al senso di precarietà e di solitudine, l’Altro è incastrato in una dinamica di supporto, di vicariamento alla quale non deve sottrarsi. In altri termini nella nostra vita affettiva da adulti, rivivremo le esperienze emotive che hanno caratterizzato il rapporto con l’Altro indispensabile dell’infanzia. La relazione che si creerà, tenderà alla ricerca di un appoggio, quasi di una protesi, che supporti una condizione di manchevolezza e di instabilità che, se non riequilibrata, creerà ansia e paura di frammentazione interiore.
Questo ha due conseguenze: in primo luogo che la relazione che così si viene a creare è una relazione altamente dipendente, dove ognuno è funzionale al bisogno di stabilità dell’altro; e in secondo luogo, elemento ancora più caratterizzante, che già nel momento della scelta del partner, si sarà inevitabilmente attratti proprio da chi può rivestire il ruolo di cui si ha bisogno: un controstampo.
Una coppia, per definirsi tale, ha bisogno di essere composta da due unità complete (nel senso di sufficientemente individuate e separate), altrimenti ci sarà solo la somma di due parti parziali, incomplete. Magari fortemente e nevroticamente intrecciate, ma non una coppia.
La perversione relazionale
Le cose possono però complicarsi ancora di più perché l’oggetto primario può non solo essere incapace di garantire il raggiungimento di una sufficiente autonomia ma, in conseguenza del proprio assetto psicologico, può creare un contesto in cui manca la sintonizzazione affettiva; contesto che determina nel bambino l’impossibilità di regolare l’intensità delle emozioni, in primo luogo la paura, che è l’emozione più potente. Gli scambi precoci col genitore divengono di conseguenza sottilmente ostili, minacciosi, inquietanti e inspiegabili e possono configurarsi come dei veri e propri maltrattamenti che includono trascuratezza, sfruttamento e abuso emotivo. Il fallimento delle strategie di attaccamento è quasi sicuramente il risultato di situazioni traumatiche non elaborate del genitore stesso che come fantasmi di ritorno scatenano la paura in risposta al bisogno di sicurezza del bambino.
Così anziché contenere e rassicurare, il genitore può costantemente spaventare e disorientare perché è egli stesso spaventato e disorientato. Come conseguenza il bambino sperimenta la paura come elemento costante, paura che diviene un’esperienza sensoriale dilagante, disorganizzante e in grado di minacciare l’integrità stessa del Sé e che può fissarsi nella memoria relazionale come una minaccia che «è» la relazione con l’altro, che prende il posto della relazione con l’altro. La forma più immediata e primaria dell’esperienza di attaccamento, può legarsi così inestricabilmente all’esperienza della paura e al senso di dolorosa e disorganizzante impotenza che ne deriva, da creare uno stampo relazionale inconscio profondamente radicato.
Se la traumaticità relazionale del contesto evolutivo rimane costante, l’esperienza mentale della disorganizzazione può tendere a diventare, in questi bambini, la risposta automatica di fronte a qualunque situazione che attivi il sistema di attaccamento. Ogni situazione di difficoltà o di vulnerabilità, sia fisica o psichica, per la quale sia necessario ricercare il contatto per essere rassicurato, ma al tempo stesso temerlo e sfuggirlo per la paura che ne deriva, ogni situazione di questo tipo può rappresentare un’esperienza di discontrollo mentale spaventosa e insopportabile. E che cosa può fare questo bambino per far sopravvivere la relazione primaria e sopravvivere egli stesso?
Deve rimodellare le manifestazioni di attaccamento nei confronti della figura genitoriale, rinunciando alla ricerca di conforto e protezione, in una strategia complessiva basata sul controllo. Deve sostituire la spontaneità della relazione con un’attenzione ed un controllo continui che lo mettano al sicuro, per quanto è possibile, dall’instabilità disorganizzante del genitore: solo in questo modo egli potrà vivere in un universo un minimo attendibile. Questa strategia sembra funzionare come difesa in grado di contrastare l’irrompere della disorganizzazione mentale, permettendo in molti casi anche dei buoni livelli di adattamento. Si realizza però a spese della possibilità di sviluppare una relazionalità autenticamente affettiva.
Questa stessa strategia verrà messa in atto ogni qual volta nel corso della vita si ricreeranno situazioni di attaccamento in grado di riattivare i vissuti di paura, di vulnerabilità e nel contempo di ricerca di vicinanza e rassicurazione che hanno caratterizzato le primissime relazioni.
Si vengono così a saldare due costellazioni psicologiche: quella dell’incapacità di essere soli, separati, che spinge a ricercare rapporti che siano fortemente intrecciati e stabilizzanti e quella che induce a relazionarsi con l’altro allo scopo di controllarlo. Quando queste dinamiche si sostanziano all’interno di una coppia ci troviamo di fronte a quella che Sandra Filippini ha definito perversione relazionale, una strategia messa in atto da uno dei due partner allo scopo di dominare l’altro, di sottometterlo, di trattarlo quasi come una cosa non umana, tutto pur di rifuggire dalle spaventose esperienze infantili di discontrollo e disorganizzazione.
Per perversione si intende una deviazione, una modificazione in senso deteriore, patologico, di un processo psichico, di un sentimento o comportamento. Nel caso di un rapporto si intende il relazionarsi con l’altro non rispettandolo nella sua integrità, ma usandolo per i propri scopi servendosi spesso, per raggiungere tale fine, di una dose di violenza caratterizzata da un’ostilità costante e insidiosa, anche se dall’esterno non appare.
Anche nel caso della perversione relazionale, come in quella della mancata soggettivazione, quando un uomo e una donna si incontrano, hanno diverse possibilità.
-Ci sono quelli che sono entrambi coinvolti in un legame di coppia perverso. In questo caso entrambi hanno una struttura della personalità che supporta dinamiche relazionali patologiche: tutti e due hanno sperimentato la paura nelle relazioni affettive primarie ed entrambi usano il controllo sull’altro per modellare il rapporto. Come nel caso delle coppie mutuamente sorreggentesi della mancata soggettivazione, l’incastro è forte ed i partner sono impegnati all’interno di un gioco perverso fondato sul desiderio di distruggere progressivamente e sistematicamente l’altro per esistere a sue spese.
-Poi ci sono quelli che hanno sbagliato l’incontro. Il tentativo di uscire dal campo da parte di soggetti sani, di troncare una relazione magari nata da pochissimo e che rivela da subito tutte le sue ombre, finisce per stimolare nell’altro, che ha magari effettuato un repentino e massiccio investimento nel legame che nasce dai bisogni primari insoddisfatti che abbiamo visto, proprio quella dimensione di terrore dell’abbandono che è alla base della necessità del controllo. In questo caso, come vedremo, le reazioni dell’uomo si differenziano sostanzialmente da quelle della donna proprio sul versante della violenza. Perché se entrambi sperimentano il terrore dell’abbandono, nell’uomo si attivano in più le basi del desiderio di possesso e del rancore che costituiscono il fondamento dell’atto violento.
-Infine ci sono quelle che all’inizio condividono il rapporto perverso ma in seguito vorrebbero cambiare l’equilibrio interno alla coppia e che, se non ci riescono, vogliono andar via. Questa decisione determina spesso una escalation di violenza, messa in atto con ogni mezzo sadico, da parte del compagno che implica talvolta il rischio per la vita della donna. Sono questi i casi di cui si occupa giornalmente la cronaca e anche noi continueremo occupandoci di questi.
Il partner per il perverso relazionale deve poter contenere la proiezione dei propri aspetti bisognosi, spaventati, impotenti e disorganizzati e, al tempo stesso, deve avere la capacità di accoglierli e di prendersene cura. Per questo non può agire da solo: ha bisogno di un altro, di qualcuno che entri in specifica, e non generica, relazione con lui.
Tali relazioni sono intrinsecamente interattive. Quando un partner perverso incontra la vittima, modellata ad esempio, da esperienze precoci di sottomissione, violenza o trascuratezza, donne che sono già state vittimizzate nel corso della loro esistenza e che tendono a rimettersi in situazioni di rischio, allora si realizza l’ingranamento, l’incastro. Perché il perverso ha bisogno di un altro e di un altro specifico, che possieda le caratteristiche che meglio si adattano alla sua dinamica intrapsichica, ha bisogno del proprio controstampo.
Ma all’inizio la relazione con un tale partner può essere molto gratificante. “La persona perversa possiede spesso un talento del tutto speciale nello stimolare, coinvolgere e affascinare l’altro: finché ha bisogno di entrare in possesso dell’altro, può essere capace di un fascino potente. Potremmo dire che è la faccia premurosa del controllo che prevale in queste prime fasi e che fa sì che il partner si senta molto coinvolto e possa avere la sensazione di vivere il rapporto più importante della sua vita.” (Filippini)
“Questo controllo premuroso, che seduce e manipola al tempo stesso, crea quella condizione di permeabilità emotiva che rende possibile l’effrazione psichica: una sorta di colonizzazione, una presa di possesso della mente dell’altro.”(Filippini) Nella relazione il partner è tenuto continuamente sotto scacco attraverso un sistematico sovvertimento della logica e della realtà, per mezzo di una modalità di comunicazione che viene sottilmente manipolata. Il perverso relazionale non comunica, si limita ad alludere; mentre rifiuta ogni autentico scambio, in quanto per lui veicolo di contenuti emotivi pericolosi, dà però l’impressione di sapere. In questo modo disorienta l’interlocutore, che non riesce a reagire. La menzogna, la derisione e il sarcasmo, l’uso di messaggi paradossali tesi a instillare il dubbio anche sulle questioni più banali (ad esempio iniziare una frase dicendo «figuriamoci se ti sei ricordata di questo, figuriamoci se hai fatto questo, ti pareva che, etc.etc.…»), sono le armi che usa per squalificare e soggiogare, per coltivare nell’altro l’idea di essere inaffidabile.
Il perverso riesce così a radicare la convinzione che lui solo sa che cosa l’altro veramente vuole, di che cosa ha veramente bisogno.
Questa dinamica lentamente e impercettibilmente erode e disorienta il senso critico della vittima. Quando il vero e proprio maltrattamento comincia a manifestarsi, la vittima non è in grado di riconoscerlo. Si perde il proprio punto di vista, e questo significa diventare deboli, incerte, insicure. Significa indebolire la propria identità ed essere indotte a pensare che sia l’altro il detentore della verità. E’ questa l’effrazione psichica e di essa è difficile rendersi conto perché avviene lentamente, a piccole dosi, coperta dalla relazione affettiva.
Vediamo come queste dinamiche si manifestano nel caso di Vanessa Scialfa, come ce le racconta Riccardo Iacona:
“Approfittando del fatto che Vanessa era chinata verso l’armadio dove stava scegliendo il giubbino da indossare, con il cavo del DVD facevo un doppio giro intorno al suo collo e mentre stringevo, l’ho tirata di peso facendola rovinare a pancia in su sul letto con le gambe penzolanti. Continuavo a stringere mentre lei non opponeva alcuna resistenza. Quando mi sono accorto che lei non respirava più ho dato uno strattone al cavo che si è spezzato, poi sono andato in bagno a lavarmi le mani. Tornato e visto che Vanessa emetteva ancora dei rantoli, ho preso un fazzoletto, l’ho imbevuto di candeggina e gliel’ho premuto sulla bocca e sul naso impedendole di respirare. Trascorsi ulteriori cinque minuti ho constatato che non respirava più, il cuore non batteva e le unghie erano diventate lilla”. Solo allora Francesco si è calmato, si è seduto su una sedia e ha pensato al da farsi. Ha fatto una morte orribile Vanessa, la sua agonia è durata decine di minuti, Francesco avrebbe potuto smettere in qualsiasi momento. Ma non l’ha fatto. Cosa ha scatenato una furia omicida così determinata?
La loro storia era cominciata cinque mesi prima. Vanessa, 20 anni, è fidanzata con un ragazzo poco più grande e lavora in un bar. Francesco ha 14 anni più di lei, è separato ed ha un figlio e inizia a fare una corte serrata alla ragazza, usa “paroline di nobiltà”, come racconta il padre, la blandisce, le fa complimenti, molti regali (maglioni, fiori, “ se l’è comprata” dice la madre), è galante, prende le difese di lei quando il ragazzo di Vanessa comincia a manifestare la sua gelosia. Finché Vanessa cede, lascia il suo ragazzo e inizia la storia con quest’uomo più vecchio di lei. Il padre di Vanessa non accetta la cosa. Litigano e lei se ne va di casa e va a vivere con Francesco. A quel punto lui non si accontenta più di andare a trovarla sul lavoro per un pò come faceva prima, ma si piazza lì per ore, la distrae, finché la titolare del bar, dopo averla richiamata tante volte, aver cercato di convincerla a non farlo rimanere tanto, è costretta a licenziarla. Così Francesco, ottenuto il risultato di aver conquistato Vanessa, subito le fa perdere il posto di lavoro. E’ un passaggio importante della storia perché, con la perdita del lavoro, Vanessa esce di scena e nessuno la vede più. A questo punto lei è completamente sola nelle mani di Francesco, ha rotto con la sua famiglia, con il suo ex ragazzo, con la proprietaria del bar, che era anche una sua amica e protettrice e anche le amiche di un tempo di sono allontanate. Dopo la lite in casa, con la madre continua ad avere contatti, ma il padre non la vuole sentire, non la perdona. Durante i 90 giorni della loro convivenza Francesco non la fa più uscire, nessuno la vede più. Se la incontravano era solo sul motorino con lui, sempre con lui. Per tre mesi sulla ragazza cala il silenzio. Si sente colo con la madre, alla quale però non racconta niente di quello che non funziona con lui. D’altra parte l’improvvisa clausura ad alcuni può apparire normale, una sorta di luna di miele. Che litigavano spesso l’hanno raccontato i vicini, si sentivano grida, urla, insulti, colpi. Anche il giorno dell’omicidio i vicini erano dovuti intervenire, avevano bussato alla porta perché dentro l’appartamento si gridava.
Francesco riferisce che la lite era cominciata per motivi di gelosia e dopo lei lo aveva sfidato “vado col primo che incontro”. Questa frase, l’onore offeso, avevano scaricato la sua furia incontenibile. Ma anche il fidanzato che lei aveva lasciato era molto geloso, quasi tutte le sere si nascondeva dietro un muretto vicino al bar e la spiava. Era il destino di Vanessa di incontrare uomini gelosi. Racconta la madre che Francesco era morboso, e forse Vanessa l’aveva capito che non era l’uomo adatto a lei e lo voleva lasciare. Per questo l’ha uccisa.
Una volta i genitori di lei, poco prima che Vanessa lasciasse la casa paterna, lo hanno affrontato, gli hanno chiesto di lasciar perdere la figlia e lui ha negato, ha detto che erano solo amici, che lui era sposato, che era troppo grande per lei, che aveva un figlio. Bugiardo e sfrontato. D’altra parte il padre si era informato: una moglie appena lasciata, un’altra donna con cui aveva avuto un figlio, mai un lavoro stabile, un po’ muratore e un po’ cameriere. Quando vivevano insieme litigavano spesso perché lui non voleva alzarsi per andare a lavorare “alle undici lo chiamavo dal lavoro e spesso lui stava ancora a letto”, aveva raccontato alla madre.
Riccardo Iacona riesce a parlare con l’ex moglie di Francesco. E’ anch’essa giovanissima, ha 24 anni e lui l’aveva lasciata un mese prima di mettersi con Francesca. Dice che ha accettato di parlare perché dopo la morte di Francesca nel giro di poco ha sentito almeno altre dieci storie di donne ammazzate dagli uomini in tutt’Italia, e pensa che sia venuto il momento che le donne conoscano un po’ meglio gli uomini con cui scelgono di avere una storia. Quando parla di lui dice che all’inizio era il ragazzo che tutte volevano: la riempiva di regali, di complimenti, la trattava come una regina. L’unica nota stonata era la gelosia: litigavano sempre. “Era convinto che l’avrei tradito, bastava incontrare una persona, scambiare uno sguardo che incominciava una tempesta che durava giorni e giorni. E pensare che ero innamorata persa, che per stare con lui sono andata contro tutti, contro la mia famiglia, i miei amici. Quando ho letto la storia di Vanessa mi sono resa conto di quanto incredibilmente simili siano le nostre storie, simile il repertorio utilizzato per conquistarci, e quanto tutte e due siamo più piccole di lui infatti la sua paura è sempre stata quella di essere dominato da una donna. “Sono io l’uomo e comando io” mi ripeteva. Era convinto che tutti lo tradivano anche se alla fine l’unico che tradiva era lui. Mi prometteva che sarebbe cambiato, che non l’avrebbe più fatto. Poi ricominciavano gli insulti, le rabbie, gli schiaffi in faccia. Anche se salutavo un amico. Non facevo che piangere dalla mattina alla sera. L’ho fatto per due anni”. Nel momento del bisogno anche lei, come Vanessa, non ha nessuno con cui confidarsi, nessuno che la possa aiutare. Una volta le torce il braccio che si gonfia, pensano che sia rotto. Al pronto soccorso al medico dice che è stato il marito, e lui le dice di lasciarlo, di denunciarlo, di non farsi trattare così. Ma lei continua ad illudersi, a sperare in un cambiamento. E quando la volta successiva con un pugno le rompe il naso, si vergogna di tornare al pronto soccorso, ci mette del ghiaccio, il naso diventa un peperone e le rimane un po’ storto. Quando lei infine gli urla di andarsene, di lasciarla, lui stranamente non reagisce. “Poi ho capito perché, aveva già preso di mira Vanessa. E’ stata la mia fortuna e la sua disgrazia”.
Francesco è ancora seduto vicino al cadavere di Vanessa quando riceve una telefonata della madre di lei, si telefonavano sempre a quell’ora. Le risponde che Vanessa non c’è, è uscita per un colloquio di lavoro. Poi lucidamente si mette all’opera: prende un lenzuolo dall’armadio, ci adagia Vanessa dentro, le ripiega le gambe sul petto per farla entrare nel piccolo portabagagli della sua auto e fa due grossi nodi per bloccarla nella posizione. Mentre sta pulendo le chiazze di sangue riceve un’altra telefonata della madre, ma lui con sangue freddo continua a rassicurarla che presto la figlia tornerà. Poi carica il corpo di Vanessa in macchina, si inoltre lungo la strada che collega Enna a Caltanissetta, si ferma a una piazzola di sosta fingendo di fare pipì e quando non passa nessuno fa scivolare lestamente il corpo oltre il guardrail. Poi arriva fino a Catania per liberarsi del borsone con gli indumenti sporchi di sangue. Quando torna a casa i genitori lo stanno aspettando. Dice che non è ancora tornata, parla di un ex fidanzato. Gli Scialfa si spaventano, corrono da carabinieri. Questi vanno a casa di Francesco, guardano, sembra tutto a posto. Lo interrogano, per 12 ore non crolla. Finché un agente gli si avvicina e gli sussurra “Guarda che Vanessa ce l’ha fatta, è fuori pericolo. Se confessi adesso non ti succederà niente”. Lui allora ha spalancato gli occhi e ha detto “Non è possibile… non può tornare più”.
Quando gli agenti accompagnano il giornalista nel luogo del ritrovamento rimangono a fissare le sterpaglie oltre il guardrail, dove Francesco ha gettato Vanessa come fosse un sacco di spazzatura.
Tutti abbiamo esperienza di relazioni di coppia particolarmente squilibrate, con una idealizzazione del compagno da parte di donne che non sembrano avere un adeguato investimento narcisistico su di sé. Donne che si sottovalutano e che amano troppo il partner. Che a lui rimangono legate a volte per un malinteso istinto materno che le porta a proteggere e tutelare il compagno, giustificando le sue debolezze anche quando loro stesse ne fanno le spese, a volte anche fisicamente.
Da ciò derivano i tentativi di giustificarlo, perdonarlo, convincersi che cambierà, che quanto accade è pur sempre amore. Gli esperti dei centri antiviolenza tendono a ripetere che non bisogna mai accettare neppure il primo schiaffo: accettandolo si manifesta scarsa autostima, si accede a una relazione al ribasso, ci si immola per salvare un’unione che sembra pesi solo su di lei. Se poi il maltrattamento avviene anche davanti agli altri, agli amici, agli estranei e lei lascia fare, non si ribella, loro penseranno che lo meriti e inizieranno a non rispettarla anche loro.
La verità è che spesso queste donne non hanno la forza e la capacità di reagire.
Molte di loro però non sono del tutto dipendenti da questo tipo di rapporto, che magari le coinvolge in momenti particolari di fragilità della loro vita, le cui conseguenze possono trascinarsi molto a lungo. Poi, magari, grazie a evoluzioni verificatesi nella loro esistenza, come il raggiungimento di una maggiore stabilità professionale ed economica o cambiamenti derivanti da un lavoro sul mondo interno che le ha portate a una maggiore considerazione per sé stesse, sentono ad un certo punto di volere cambiare anche gli equilibri all’interno della coppia e non si prestano più a funzionare solo come fondamento della sicurezza narcisistica dell’altro. Quando non ci riescono possono scegliere di rompere il legame: si rivolgono ad un centro per le donne, cercano aiuto, diventano più capaci di ribellarsi, smettono di sentirsi vittime predestinate o sante redentrici. Costa in ogni caso moltissimo dover ammettere di aver fallito, di aver sposato un violento, un orco, di aver subito per tanto tempo. Ma la maggioranza delle donne che vengono uccise sono proprio quelle che sono state vittime di violenza per più tempo. Certo occorre distinguere, per tornare al primo schiaffo, se esso arriva occasionalmente nel corso di una discussione, come potrebbe accadere anche in frangenti diversi dal rapporto di coppia. Ma quando lo schiaffo “è” l’esito di una strategia, quando risponde al preciso disegno di sottomettere l’altro, allora non rappresenta che l’inizio di una violenza esplicita che può non fermarsi più.
Ma esiste un’altra faccia della medaglia: le persone che maltrattano gli altri allo scopo inconscio di utilizzarle per esteriorizzare i propri conflitti tendono a diventare estremamente dipendenti dalle loro vittime. Il carnefice è degradato quanto la vittima, diceva Sartre, e viceversa. E’ un punto fondamentale per capire la forza di un attaccamento perverso. Tale dipendenza è tanto inconsciamente potente quanto consciamente insopportabile, riecheggia fortemente la pericolosa dipendenza infantile e deve essere esteriorizzata violentemente con la conseguente squalificazione del partner, ottenendo una sorta di trionfo che sconfigga almeno momentaneamente il senso di confusione e paura riattualizzato dalla stessa vicinanza affettiva. E questo deve essere ripetuto all’infinito. Perciò la recidiva è il maggiore indicatore di pericolosità. Anche se l’uomo violento smette per un mese, anche se ha giurato davanti ai figli, le sue dinamiche interiori non gli consentono di non tornare a farlo. Se poi le minacce aumentano in ferocia tipo “ti taglio la gola, ti faccio a pezzi” e includono anche la minaccia di suicidio, se comincia a far del male ai figli o a non rispettare i dispositivi di legge (star lontano, non telefonare etc.), allora significa che il limite è stato passato, che sente di non aver più nulla da perdere, e la situazione è talmente pericolosa che può esitare nel femminicidio.
In questi casi si assiste ad una vera escalation, più l’uomo si sente in pericolo, più riprendono vita e ingigantiscono dentro di sé i fantasmi disorganizzanti e spaventanti dell’infanzia relativi al bisogno di vicinanza e alla paura di abbandono, più si scatena la cosiddetta violenza “auto-protettiva” in cui l’altro è percepito come un pericolo immediato che deve esser eliminato, senza nessun interesse per tutto quello che può comportare.
L’abbandono non può essere tollerato perché riattualizza il terrore senza nome dell’essere soli, insieme alla certezza che non si incontrerà mai più nessuno che abbia quelle caratteristiche personali così rassicuranti. La frase più tipica pronunciata dagli uomini prima di uccidere la loro partner e prima, spesso, di uccidere anche se stessi è proprio “senza di te non posso più vivere”. Con la certezza assoluta che sarà così per sempre, che la vita non avrà più senso alcuno.
E’ come se in quei momenti fosse cieco, dimentico di tutto e totalmente disperato.
“Gli uomini che uccidono le donne è come se vivessero in un mondo loro, dove sono altri i pericoli, le priorità. Non pensano al futuro, né al loro né a quello dei loro figli. Pensano a come scaricare tutto sulla propria donna, a come annientarla, cancellarla. L’ossessione cancella la realtà, e non sembrano preoccuparsi del cumulo di dolore che generano e che travolge intere famiglie”. (R. Iacona)
Solo dopo l’agito violento questi uomini ritrovano la calma, hanno un calo di tensione, come il ripristino di una stabilità interiore, uno strano stato di tranquillità. La calma rappresenta la riuscita distruzione del pericolo di frammentazione e disorganizzazione. E la compagna è stata ancora una volta solo il veicolo dei propri processi proiettivi patologici.
Leggiamo ora il caso di Sabrina Blotti:
Così Sabrina racconta ai carabinieri di Cesena nell’aprile 2012 l’inizio della sua breve storia d’amore con Gaetano Delle Foglie, un uomo più grande, come lei originario di Bari e padre della sua migliore amica Cinzia:” Ho cominciato a frequentarmi con Gaetano alla fine di febbraio 2012, la nostra frequentazione è durata circa un mese. Dopo un mese decido di lasciarlo, di non andare avanti con questa storia e ad Aprile, visto che non avevo cambiato idea, Gaetano torna a Bari, non prima di avermi insultato pesantemente in macchina alla presenza di mio figlio e della figlia di Cinzia. Nonostante i ripetuti tentativi di calmarlo, anche perché c’erano i bambini, non ha sentito ragione e ha continuato a gridarmi troia e puttana”.
Appena arrivato a Bari l’uomo incomincia a tempestare di telefonate Sabrina. “Inizialmente non gli ho mai risposto” continua a dire la donna ai carabinieri.” Credo di averlo fatto solo in tre occasioni, la prima quando mi chiede di andare con lui alle isole Tremiti in vacanza, e quando gli dico che non andrò mi minaccia di morte “Non arrivi al 27 perché ti uccido prima e chiunque ti sta vicino morirà con te. Voglio fare una cosa eclatante, o davanti alla scuola di tuo figlio o davanti all’agenzia dove lavori”. “Gli ho risposto anche nella telefonata del 17 Aprile, Gaetano mi ha ripetuto l’invito ad andare alle Tremiti, e al mio rifiuto ha ripreso a minacciarmi. Nella stessa circostanza mi diceva che si era procurato l’arma con la quale mi avrebbe uccisa. Non mi avrebbe fatto soffrire” ha aggiunto” e poi si sarebbe ucciso pure lui. L’ultima telefonata è di questa mattina. Mi trovavo a casa di sua figlia Cinzia, ha insistito ancora col progetto della vacanza e visto che ero irremovibile mi ha detto “trascorri tranquilla questo ultimi due o tre giorni insieme ai tuoi figli perché saranno gli ultimi. Ho bisogno di sistemare delle cose, poi vengo su”. Con la denuncia Sabrina chiede ai carabinieri di adottare ogni necessario strumento al fine di tutelare lei e i suoi figli.
Sabrina ha 45 anni, è divorziata ed ha due figli: una ragazzina di 14 anni ed un bambino di 6. I rapporti con l’ex marito sono cordiali e rispettosi, collaborano nell’accudimento dei figli e tra loro non ci sono problemi. “E’ stata una separazione consensuale la nostra, dopo quasi vent’anni di matrimonio” dice il marito “l’amore era finito, ma i rapporti erano ottimi sia per quanto riguarda la cura dei bambini che per la stima reciproca, eravamo due persone adulte che si stimavano”. Il marito è un maresciallo dell’aeronautica militare che, dopo la separazione, ha lasciato a Sabrina ed ai figli l’appartamento in cui vivevano ed è andato a vivere in un alloggio nella caserma.
Gaetano ha 15 anni più di lei, la storia non dura molto perché Sabrina si accorge che quest’uomo, che sembra aver investito molto su di lei, è instabile.
La denuncia scatta perché proprio la mattina del 19 aprile Cinzia, l’amica di Sabrina e figlia di Gaetano, riceve una telefonata da una dottoressa di Bari, conoscente della famiglia perché medico curante di Gaetano, che le dice di essere appena tornata dalla caserma dei carabinieri dove ha sporto denuncia contro il padre, perché questi durante la visita medica le ha raccontato tutta la sua storia con Sabrina e le ha anche detto che poiché quest’ultima non vuole acconsentire ad un incontro chiarificatore, sta per partire per Cesena per ammazzarla. Saputo questo Sabrina corre a fare la denuncia. I carabinieri della stazione di Noicottaro in Puglia, dove risiede Gaetano, si recano a casa sua con un mandato di perquisizione per cercare la pistola che lui aveva dichiarato alla dottoressa di possedere: non la trovano, ma ora Gaetano sa che Sabrina lo ha denunciato. I carabinieri di Cesena decidono di fare servizio di sorveglianza, sia pure occasionale, attorno a Sabrina anche perché la stessa stazione dei carabinieri di Noicottaro comunica ai carabinieri di Cesena che due giorni prima il figlio maschio di Gaetano aveva richiesto l’intervento di una pattuglia perché il padre sotto casa stava minacciando lui e la moglie con un coltello. Le denunce sono tante, ma nessuno mette sotto sorveglianza Gaetano che parte e arriva a Cesena la mattina del 31 maggio, incontra Sabrina, che ha appena accompagnato il bambino a scuola, proprio sotto la casa della figlia, le urla che non può vivere senza di lei, e mentre la donna si gira per scappare, la uccide con due colpi di pistola. Poi fugge in macchina e si rifugia dentro il duomo di Cervia. Nel duomo arrivano poliziotti, negoziatori, psicologi. Riescono ad avvicinarsi fino a pochi metri da lui, ma non possono sopraffarlo, lui ha sempre in pugno la pistola e ogni tanto la punta contro i carabinieri. Dice che si sente ingannato da Sabrina perché lui voleva ricostruirsi una vita con lei, che aveva fatto dei progetti, che era vedovo da parecchi anni. I carabinieri continuano a fargli domande, cercano di farlo parlare. La cosa va avanti per circa quattro ore, sanno che Gaetano è stanco, ha guidato per tutta la notte e non ha dormito neanche la sera precedente perché è stato a cena con degli amici a Bari. Sperano che crolli ed infatti per qualche minuto Gaetano sta zitto, non risponde alle domande, si gira di spalle ai carabinieri e posa la pistola sull’altare. Tutti pensano che stia per consegnarsi, ma in un attimo riafferra la pistola e si spara al petto.
Era un omicidio-suicidio annunciato quello di Gaetano, eppure sembra che in casi come questo, forse anche a causa delle ristrettezze della legge che non consente di intervenire se non quando il reato si è consumato, non ci sia nulla che possa impedire agli eventi di avverarsi così come minacciato, come se possedessero una forza inarrestabile, quasi come un destino inevitabile.
In conclusione. Ho delineato due scenari possibili, che possono coesistere e nel caso della violenza coesistono sempre. In quello dell’insufficiente soggettivazione la ricerca dell’altro è condizione per trovare il proprio completamento. Queste coppie possono durare molto a lungo perché si sorreggono a vicenda e per questo le separazioni sono difficili, anche se il rapporto che ne deriva è privo di libertà e di possibilità di crescita perché ricalca coattivamente le dinamiche non soggettivanti dell’infanzia. In questo primo caso la partecipazione alla stabilità della coppia di uomo donna è equamente distribuita, modalità di attaccamento e incapacità di separarsi sono condivise pienamente e solo il desiderio di liberarsi da un legame ferreo può determinare un cambiamento. Il secondo scenario, quello della perversione relazionale basata sul controllo dell’altro in cui la violenza è inevitabile e che è più strettamente legato all’universo maschile, lo troviamo sempre saldato al primo. In questo caso la vittima è costretta a subire violenze e umiliazioni. Quando si ribella, dopo un tempo più o meno lungo e decide di lasciare, l’abbandono può provocare nell’uomo le reazioni che abbiamo visto. In entrambi i casi viene rispettata la regola dello stampo e del controstampo, altrimenti le relazioni verrebbero interrotte subito.
L’anno scorso un programma di Radio tre ha intervistato alcuni uomini che avevano fatto violenza alle donne. Ha detto uno di loro: “Per l’uomo è difficile rimettersi in discussione. All’inizio non capisce perché lei se n’è andata, perché la violenza è come una scala, sali un gradino per volta, non ti accorgi di dove sei arrivato. Anche perché la violenza ti dà l’illusione del potere, e invece è solo fare del male a se stessi e agli altri. E a volte può succedere che ti si spegne la luce e dopo la prima coltellata ne dai altre trenta. Oggi penso che quando l’uomo diventa aggressivo nei confronti della propria compagna ha dentro di sé paura, una grande paura. Io avevo paura di rimanere solo.”
Nel film “Crimini e misfatti” del 1989 Woody Allen fa dire a Louis Levi, personaggio-filosofo scampato all’Olocausto che alcuni hanno identificato con Primo Levi, una frase che mi sembra possa compendiare quanto detto oggi: “Quando ci innamoriamo si ha uno stranissimo paradosso per cui stiamo tentando il ritrovamento di tutte o di alcune delle persone a cui eravamo attaccati da bambini e, per altro verso, chiediamo alla persona amata di correggere ognuno di quei torti che quegli originari genitori o fratelli ci hanno inflitto nella verde età, cosicché l’amore tiene in sé la contraddizione di un tentativo di tornare al passato e di un tentativo di annullare il passato”.