Quando si riflette sul problema del masochismo ci si sente su un terreno particolarmente scivoloso. Agli psicoterapeuti viene di solito richiesto di alleviare la sofferenza, nel caso del masochismo invece la ricerca della sofferenza sembra essere il fine ultimo dei comportamenti del paziente. Il masochista ricerca la sofferenza direttamente, scientemente: “se c’è la possibilità di prendere uno schiaffo” diceva Freud “il vero masochista ci mette la faccia”.
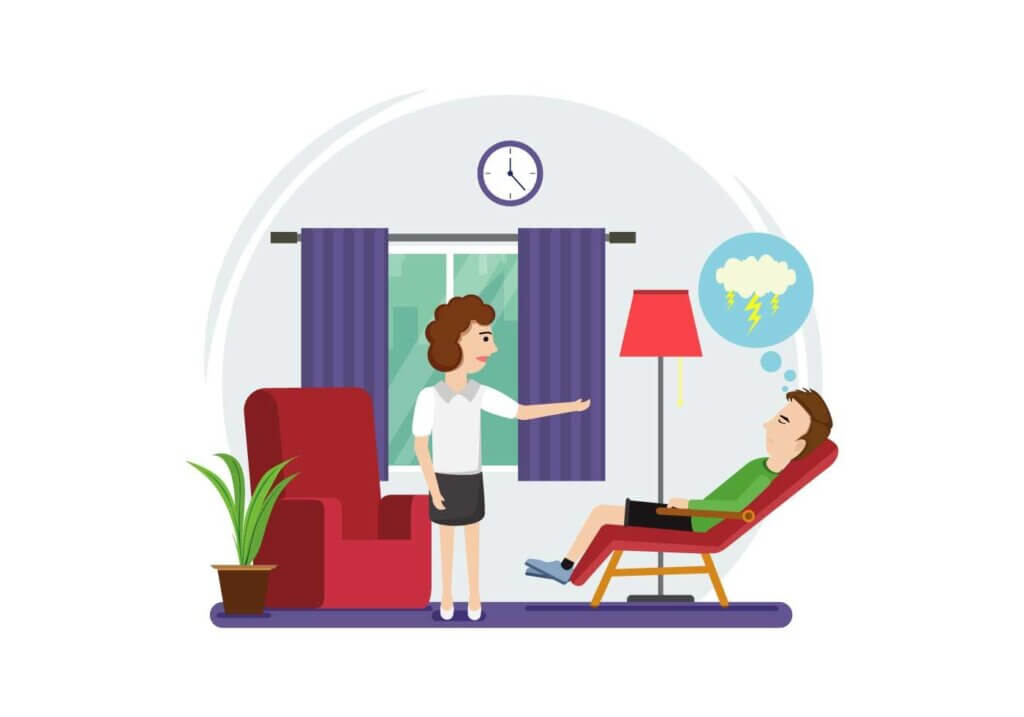
In senso generale possiamo distinguere due tipi di masochismo: uno di carattere sessuale, il cosiddetto masochismo erogeno, più conosciuto per la singolarità dei comportamenti che genera, dove la ricerca della sofferenza è necessaria al soddisfacimento erotico, ed un altro di carattere morale, che ha caratteristiche meno marcate e meno facilmente riconoscibili ad un’osservazione superficiale, ma che investe e danneggia tutta la vita dell’individuo, senza procurare inoltre, apparentemente, alcun tipo di gratificazione.
Un esempio di masochismo morale, ed anche della commistione tra questo e quello sessuale è stato ben descritto dal regista Joseph von Sternberg nel 1931 nel film “L’angelo azzurro”, tratto dal romanzo di Heinrich Mann, che racconta la storia infelice del professor Unrath, stimatissimo professore, che in età ormai avanzata perde la testa per una ballerina. Il film e’ notissimo per l’interpretazione di Marlene Dietrich ed Emil Jannings e la sua connotazione di godimento sessuale è evidente nonostante, o proprio a causa, degli innumerevoli patimenti del professore.
Cominciamo allora proprio con uno sguardo storico al masochismo sessuale.
La strana relazione tra il dolore e la voluttà, tra la sofferenza e il sesso è conosciuta fin dai tempi più antichi. Accanto a numerosi resoconti che risalgono a personaggi del vecchio testamento sono state tramandate anche rappresentazioni molto esplicite, tra queste una che raffigura addirittura Aristotele che stando carponi sorregge sulla schiena una donna armata di frusta.
Nel corso dei secoli sono state numerose le narrazioni di percosse, umiliazioni, flagellazioni che venivano inferte a scopo sessuale. Ma ciò che caratterizzava queste descrizioni era che tali pratiche venivano considerate solo dei mezzi di eccitazione, una specie di afrodisiaco preliminare all’atto sessuale vero e proprio.
E’ soltanto nel XIX secolo che il masochismo viene invece descritto come una perversione sessuale dove la differenza consiste proprio nel fatto che in una perversione il piacere è dato dalla pratica perversa in sé. L’atto sessuale normalmente inteso, infatti, nella perversione non ha bisogno di essere consumato, e di norma viene evitato.
Fu Krafft-Ebing che nel 1869 nel suo “Psicopatologia Sessuale” descrisse per primo in maniera accurata questa perversione caratterizzandone l’atteggiamento servile verso la donna, la ricerca dell’umiliazione e della punizione fisica ritenute indispensabili ai fini del godimento sessuale.
Lo studio di Krafft-Ebing rimane il documento più completo che abbia preceduto gli studi psicoanalitici. E’ a Krafft-Ebing che dobbiamo la denominazione di masochismo; la ricavò dal cognome dello scrittore austriaco Leopold Von Sacher-Masoch che divenne celebre ai suoi tempi per le sue opere, un centinaio di racconti e romanzi, dal contenuto sorprendentemente monotono: un uomo diventa per amore oggetto delle peggiori umiliazioni e subisce ogni tipo di crudeltà. Le donne dei suoi racconti sono sempre belle, autoritarie, vestite di pellicce ed armate di frustino.
Nel suo “capolavoro” “Venere in pelliccia” un uomo subisce le solite umiliazioni per amore e per giunta viene anche picchiato ed umiliato dall’amante di lei.
Non si può dire che Sacher-Masoch fosse incoerente: per anni ha lottato con la moglie perché lei si prendesse un amante e quando alla fine ci riuscì ottenne anche di essere picchiato ed ingiuriato da lui. Riporto a titolo di esempio uno stralcio di uno dei contratti che Sacher-Masoch stipulava con le sue amanti o con la moglie. Queste una parte delle richieste della donna:
Mio schiavo, queste le condizioni per cui vi tollero vicino:
Rinuncia assoluta al vostro Io e alla vostra volontà.
Siete nelle mie mani un istrumento cieco che esegue tutti i miei ordini senza discuterli.
Tutto quanto vi sarà accordato di piacevole è una grazia da parte mia e io agirò senza riguardo e non avrò alcun dovere.
Come il vostro corpo anche la vostra anima mi appartiene.
Voi dovrete compiere tutto ciò che vi chiederò. Etc. etc.
A Krafft-Ebing non sfuggirono naturalmente né il fatto che masochismo e sadismo sono spesso presenti nella stessa persona (in fondo era Sacher-Masoch che redigeva i contratti), né la presenza nei comportamenti ora citati di fantasmi del passato, ma egli attribuì il primo ad una coincidenza, ed i secondi al dettato costituzionale.
Bisogna attendere il Freud del 1905 ed i suoi “Tre saggi sulla teoria sessuale” per veder stabilire uno stretto nesso tra sadismo e masochismo. Per quanto riguarda il sadismo, dice Freud, non è difficile immaginare la sessualità mescolata con una certa aggressività, risultante forse dall’inclinazione alla sopraffazione tesa a superare la resistenza dell’oggetto sessuale in caso di fallimento del corteggiamento allo scopo di assicurarsi l’accoppiamento e quindi la riproduzione. Il sadismo corrisponderebbe allora alla componente aggressiva della sessualità che si è resa indipendente ed esagerata.
Il masochismo sembra allontanarsi di più dalla meta sessuale, con il suo rivolgere verso se stessi l’aggressività sadica, pur se è noto a tutti, dice Freud, che ogni sensazione di dolore contiene in sé anche la possibilità del piacere, pur se non è ancora chiaro perché.
Nel 1915, in “Pulsioni e loro destini” fa un passo in avanti e vede nella sostituzione della propria persona al posto dell’oggetto da martoriare, e nella ricerca della persona che infligga la punizione, l’essenza del masochismo.
Ma è con lo scritto del 1919 “Un bambino viene picchiato”che viene fornita una chiave di lettura del masochismo che ne spiega anche il meccanismo di formazione.
Alcuni pazienti di Freud raccontarono di alcune loro frequenti fantasticherie infantili a proposito di un bambino che viene picchiato. Ammettevano con esitazione la fantasia, provando vergogna e senso di colpa perché essa si coniugava invariabilmente con un senso di eccitazione sessuale che spesso conduceva ad un soddisfacimento masturbatorio. Non si sapeva a cosa si riferisse la fantasia, se a fatti a cui si era assistito o immaginari, né si sapeva chi era il bambino picchiato, se era maschio o femmina, né chi era che picchiava.
Come si sa in psicoanalisi, quando i ricordi sono così confusi è perchè è intervenuta la rimozione che ha steso il suo velo sui ricordi infantili.
L’indagine condusse a suddividere la fantasia in tre fasi. Nella prima emerse che il bambino picchiato non è mai quello che fantastica, il bambino picchiato è per lo più un altro bambino, preferibilmente, se esiste, un fratellino o una sorellina. La persona che picchia, nel caso della bambina almeno, diviene sempre riconoscibile come il padre. Quindi la prima fase della fantasia si riassume nella frase “mio padre picchia il bambino”. Questa prima fase è ricordata abbastanza facilmente e si può collegare senza difficoltà alla gelosia infantile nei confronti dei propri fratelli con i quali si è costretti a dividere le attenzioni e l’amore dei genitori. La frase sarebbe quindi più completa se suonasse così “mio padre picchia il bambino che io odio, quindi ama soltanto me”.
La seconda fase della fantasia cambia completamente il suo enunciato e suona così “vengo picchiato da mio padre”. Al contrario della prima, questa fase è di carattere indubbiamente masochistico e si differenzia ancora dalla prima perché essa è totalmente inconscia, non viene ricordata, è una ricostruzione che avviene nell’analisi, ma essa è importantissima per comprendere il senso della fantasia. Come è potuto accadere questo rovesciamento? Per spiegarlo facciamo riferimento alla fase che sta attraversando il bambino in questo periodo, che è la fase del cosiddetto complesso di Edipo. Come è noto questa fase si manifesta verso il quinto anno di età, è caratterizzata da un intenso attaccamento per il genitore di sesso opposto ed una altrettanto intensa rivalità per il genitore dello stesso sesso. E’ una fase fondamentale dello sviluppo psico-sessuale perché dal modo in cui sarà superata dipenderà sia il futuro orientamento sessuale che l’organizzazione ed il funzionamento della propria vita psichica, anche se occorre ricordare ancora una volta che in ogni caso il modo in cui si perviene ad una fase successiva è sempre condizionato dal modo in cui sono state superate le fasi precedenti, come ci ha ricordato con la sua opera Erik Erikson.
La fase edipica termina per circostanze esterne (per es. la nascita di un fratellino che testimonia “l’infedeltà” dell’oggetto amato perché i bambini capiscono presto che nelle gravidanze c’entrano entrambi i genitori ed i loro organi sessuali), o per circostanze interne, come un appagamento troppo a lungo agognato e che non si realizza, o per il concorso di entrambe, ma soprattutto perché la persona che viene vista come rivale, il padre o la madre, è anche la stessa persona che amorevolmente si prende cura, che protegge, che ama e che si ama. Ed allora il bambino, ripetendo e ricapitolando in questo la storia dell’umanità, rimuove la scelta incestuosa e prosegue nel suo cammino evolutivo non più rivaleggiando con il genitore dello stesso sesso ma, identificandosi con lui, ne acquisisce l’identità sessuale e molte delle caratteristiche che confluiranno poi nella personalità totale, nel suo Super Io e nell’Io Ideale.
I processi di rimozione dei sentimenti incestuosi provati per il genitore di sesso opposto e di quelli aggressivi provati per il genitore dello stesso sesso esitano in un senso di colpa come esito, nel caso della fantasia in esame, conduce all’immagine dell’essere picchiati. E’ come se il senso di colpa esprimesse il proprio trionfo con una dura punizione “ti picchia perché non ti ama perché sei stato cattivo”. Dice Freud “il senso di colpa è invariabilmente l’elemento che trasforma il sadismo in masochismo”. E’ un’affermazione importante: spiega perché accade che l’aggressività prima diretta verso l’esterno ora ritorni invece verso il soggetto in forma di punizione per i cattivi pensieri e desideri.
Ma il ciclo della fantasia non è ancora terminato: c’è una terza fase, quella che viene ricordata più facilmente.
In questo caso chi picchia è generalmente un maestro o un’altra figura adulta, e i bambini picchiati sono in genere numerosi. Ora la fantasia ha di nuovo un carattere sadico e quello che la differenzia dalle altre due fasi è il piacere che essa procura e che risponde ad un’eccitazione sessuale.
Cosa è accaduto, perché la fantasia si è di nuovo trasformata in atto sadico, perché il senso di colpa sembra ora scomparso per lasciare il posto addirittura al piacere?
Torniamo ancora al nostro bambino alle prese con l’Edipo. Egli si trova nella fase cosiddetta fallica del suo sviluppo psico-sessuale. La rimozione che colpisce i suoi sentimenti incestuosi e aggressivi procura anche una regressione della sua organizzazione genitale. In alcuni bambini la regressione conduce fino alla fase ancora precedente detta sadico-anale, che appunto per il suo carattere sadico, complicata dal rovesciamento operato dal senso di colpa di cui sopra, trasforma la frase “mio padre mi ama e picchia gli altri bambini” nella frase “mio padre mi picchia”. Ricordiamo che la frase “mio padre mi picchia” appartiene alla seconda fase della fantasia, è totalmente inconscia e per questo non viene colta la combinazione di sensualità ed erotismo che contiene. Voglio qui sottolineare che quando parliamo di sessualità infantile, non dobbiamo riferirci al modo adulto di intendere la sessualità. Per il bambino la sessualità è il piacere tratto dallo sperimentare le sensazioni piacevoli che vengono dal suo corpo, che sono parziali perché riguardano parti e non tutto il corpo e che definiscono principalmente un modo di funzionare. Nel caso della fase sadico-anale, un tipo di sensualità che si esprime attraverso il controllo dei meccanismi espulsivi-ritentivi tipici per esempio della battaglia del vasino. In questa fase c’è anche la scoperta dell’aggressività come piacere, intesa sia nel senso di controllo e dominio dell’ambiente circostante che proprio del piacere dell’aggressività (ritroveremo questa caratteristica nella tipica crudeltà degli adolescenti verso gli animali, perché l’adolescenza ricapitola nei suoi vari momenti tutte le fasi che l’hanno preceduta). Quindi la frase “mio padre mi picchia” risulta dalla regressione alla fase sadico-anale che fornisce l’eccitamento libidico al fatto del picchiare, e dalla complicazione introdotta dal senso di colpa che per punizione trasforma, rovescia il picchiare nell’atto passivo del piacere di essere picchiato. “E non è proprio questa, finalmente, l’essenza del masochismo? ” afferma Freud.
I numerosi bambini della terza fase che vengono picchiati dal maestro o da altri adulti non sono altro, allora, che sostituti del bambino il quale, tramite questi spostamenti, può continuare a utilizzare la sua fantasia, trarne piacere e non ricollegarla ai fenomeni dolorosi che l’hanno preceduta.
Quanto evidenziato nella sfera sessuale si verifica naturalmente anche in quegli aspetti del masochismo che possiamo definire morali. Le caratterizzazioni comportamentali del masochismo, come possiamo immaginare, sono tantissime. Theodor Reik nel suo “Il masochismo nell’era moderna” ne ha catalogati diversi. Ha parlato di masochismo verbale per chi ama sentirsi dire parole offensive e umilianti, di masochismo sociale per chi ama un atteggiamento di subordinazione e di sottomissione, di masochismo di massa per chi rinuncia alla propria individualità all’interno di masse entusiaste e devote a chi rappresenta una propria immagine idealizzata. Ma sono sicuro che ciascuno riferendosi alla propria esperienza potrebbe elencare altri tipi di masochismo, tutti caratterizzati da questa ricerca attiva della sofferenza.
A questo punto ci si potrebbe chiedere: ma se il superamento del complesso di Edipo è una fase indispensabile e universale perché in alcuni casi prende una direzione che poi porterà, per esempio, al masochismo, ed in altri no? Ci addentriamo qui in un terreno molto accidentato perché, nonostante tutti gli sforzi non si è ancora riusciti a comprendere che direzione prenda lo sviluppo in presenza di una data esperienza. Sappiamo che la stessa esperienza, per esempio un trauma, può avere un impatto emotivo totalmente diverso in persone diverse, così come lo stesso trauma può essere vissuto in maniera totalmente differente secondo il periodo della vita in cui accade.
Quello che si è riusciti almeno in parte a fare è tentare di spiegare retrospettivamente ciò che una data esperienza può aver significato per quella persona, e da questo provare a trarre qualche generalizzazione.
Cerco di illustrare con un caso clinico quanto detto finora.
All’inizio degli anni ’80 rimasi molto colpito da un film statunitense intitolato “Looking for Mr. Goodbar”. Il titolo era in Inglese anche nella versione italiana perchè di fatto in Italiano “In cerca di Mr. Goodbar” non significa granché. Una breve ricerca mi aiutò a sapere che Mr. Goodbar per gli Americani è il corrispettivo del Godot di Samuel Beckett: qualcuno o qualcosa che si aspetta o si ricerca ma che non si trova. Il film era diretto da Richard Brooks ed interpretato da Diane Keaton, futura moglie di Woody Allen, e tra gli altri, da un giovanissimo Richard Gere.
La protagonista Diane Keaton vive col padre, la madre ed una sorella minore. Diane risulta essere la figlia sbagliata, piena di malanni, perennemente in lotta col padre e debolmente difesa dalla madre. Le scene di vita in famiglia sono presentate come una serie di feedback a punteggiare la vita affettiva di Diane che è molto movimentata e piena di insuccessi. La sua fragilità nell’alternarsi delle varie storie, le sue illusioni e disillusioni, la ricerca e l’insoddisfazione, il bisogno di essere amata e la sensazione di sentirsi più svuotata, più umiliata e più abbrutita dopo ogni relazione finita male è raccontato dal regista senza prendere posizione, senza offrici soluzioni interpretative, assumendo quasi egli stesso l’atteggiamento dello spettatore che sta a vedere come va a finire. E la fine si delinea a poco a poco: ogni nuova avventura è sempre più breve e vissuta nel segno della ripetizione di esperienze via via più degradanti e autodistruttive fino all’epilogo tragico, ed in fondo atteso, della morte di lei per mano di un’altra delle solite avventure rimediata in un bar.
Come in ogni buon film il senso di partecipazione allo spettacolo è forte, la trepidazione per le sofferenze della protagonista autentica, ed autentico è anche il senso di immedesimazione.
Perché, ci si chiede, la protagonista non si accorge che i suoi uomini sono la fotocopia l’uno dell’altro? Perché non vede che uguali sono le situazioni, gli esiti che generano, le emozioni che le provocano? Come spettatori ce ne rendiamo conto. Come ci rendiamo conto che Diane ricerca l’approvazione, la stima, l’amore e che li ricerca in chiunque le faccia anche solo balenare l’idea che la sua fame sarà saziata, senza chiedersi se quanto le viene offerto finirà per avvelenarla.
I frequenti feedback aiutano lo spettatore a capire che per Diane il suo Mr. Goodbar è la figura paterna, che negli altri uomini ricerca l’affetto e la considerazione che avrebbe desiderato ottenere da lui, ma che sta proprio in questa sostituzione ciò che vanifica la sua ricerca. Ma se lo spettatore riesce a comprenderlo, perché Diane no? Perché si tortura in questo modo? Perché continua a farsi trattar male, a farsi disprezzare ed umiliare?
Proviamo a trovare qualche risposta alla domande che ci poniamo su Diane seguendo la storia clinica di Anna.
Anna ha venticinque anni quando la vedo per la prima volta. È una bella ragazza mora, non molto alta. Come Diane anche lei vive con padre, madre e una sorella. Lei è la più grande, i genitori si sono sposati quando già la aspettavano. Anna riferisce che i suoi litigano continuamente, sono chiaramente scontenti l’uno dell’altra, e questo la fa sentire in colpa, pensa che la responsabilità sia sua che in qualche modo li ha costretti a sposarsi. Mentre la madre sembra chiusa in una sua impenetrabilità depressiva e ansiosa dove non c’è spazio altro che per le sue lamentele e la sua rabbia repressa, il padre sembra trovare un momento di allegria e di sollievo solo quando si rivolge alla sorella di Anna. Anna si è resa conto da sempre di questa preferenza, se ne è sempre sentita ferita, ci ha lottato contro come ha potuto. Non c’è stato niente da fare.
Con dolore narra e rinarra dell’ attesa ansiosa del padre alla sera, dell’eccitazione al pensiero di mostrargli l’ennesimo bel voto preso a scuola. L’approvazione del padre arrivava sì, i complimenti anche, ma senza gioia, senza quella gioia che gli vedeva negli occhi per qualunque cosa facesse la sorella. Ed in Anna scendeva allora quel gelo che solo i genitori a volte sanno suscitare: un gelo che generava una rabbia sorda prima di tutto verso se stessa. In camera sua si mordeva con forza le mani fino a farle sanguinare per provare un dolore che la distraesse da quello che sentiva dentro.
Un giorno accompagnò il padre dal meccanico. Era felice perché si era appena diplomata e si stavano preparando per andare in vacanza, e poi era sempre contenta quando poteva stare col padre. All’auto serviva un controllo prima della partenza. Il padre e il meccanico erano evidentemente amici, scherzavano e c’era complicità tra loro. Il meccanico si interessò subito a lei, fece i complimenti al padre per una così bella ragazza, e mentre era chino sulla macchina la guardava con una sorta di impudenza, come lei mi raccontò.
Tornati dalle vacanze telefonò immediatamente al meccanico, che era sposato e aveva due figli. La relazione durò poco e Anna si chiese a lungo perché aveva scelto proprio lui per la sua prima volta. Quando cominciai a vederla, la lista delle avventure era ormai molto lunga. Non era quasi più importante che gli uomini che incontrava le piacessero o meno, si sentiva come costretta ad allungare la lista. Ma non era per il disordine della sua vita affettiva che mi aveva contattato, ma perché da due anni una depressione le aveva fatto interrompere gli studi e lasciare l’Università.
Ci volle molto tempo perché cominciasse a rendersi conto che era la sua stessa condotta avvilente e autodistruttiva che le impediva di curarsi in maniera diversa di quegli aspetti di sé che, così trascurati, generavano un malessere sempre maggiore.
Perchè Anna, già all’inizio della terapia, si rendeva conto che la sua promiscuità sessuale rappresentava il sostituto di qualcos’altro, l’ennesimo uomo non l’avrebbe aiutata a sentirsi meglio, nondimeno non riusciva a comportarsi diversamente, non poteva fare altro per calmare almeno temporaneamente l’angoscia che la opprimeva, anche se sapeva che dopo sarebbe stata peggio. Quando mi raccontava delle sue avventure spesso mi dava l’impressione di sentire gli uomini come i tossicodipendenti sentono le sostanze: pericolose ed indispensabili.
Perché allora, se “si sa”, se si ha consapevolezza, perchè Anna e Diane ripetono i loro comportamenti?
E’ contenuto proprio in questo verbo “ripetere”, il significato di quanto stiamo cercando.
In ogni psicoterapia arriva il momento in cui il paziente inizia a reagire al terapeuta come se questi fosse una delle persone significative del suo passato. Il paziente usa quello che accade nella terapia per incastonarlo nella sua storia passata e rivivere nel qui ed ora, emotivamente, quanto proviene da allora: nel ripetere appunto, nella terapia, esperienze del passato. Il terapeuta diventa di volta in volta qualcuno da amare, da blandire, da temere, con il quale arrabbiarsi, discutere etc. E’ la cosiddetta nevrosi di traslazione e all’interno di essa si realizza quella incessante e ineluttabile ripetizione che proprio per questa caratteristica di coercizione Freud chiamò coazione a ripetere, con la mente rivolta al Nietzsche dell’”eterno ritorno dell’uguale”.
Il paziente è totalmente inconsapevole di quanto sta mettendo in atto, è compito dell’interpretazione mettere in luce quanto sta accadendo, operando una sorta di disvelamento. Per inciso l’analisi della traslazione, o transfert, momento fondamentale e centrale della terapia, è l’elemento che più di ogni altro differenzia la psicoanalisi da tutte le altre forme di psicoterapia.
Aggiungiamo che il lavoro di interpretazione del trasfert, anche su uno specifico problema, si ripeterà molte e molte volte nel corso della terapia. Non basta una chiarificazione per modificare un comportamento dettato dalla coazione a ripetere. Se non fosse così, le terapie diverrebbero molto più brevi.
La coazione a ripetere è un cardine di tanta elaborazione psicoanalitica perché è anche un cardine del funzionamento della vita psichica.
Gran parte dei comportamenti, dei pensieri e delle emozioni rispondono ai dettami della coazione a ripetere. Ci si accorge dei suoi effetti quando si guarda alle scelte affettive, come dimostrano gli esempi di Diane e di Anna, o come hanno chiaramente mostrato numerose inchieste che sono state condotte in paesi come gli Stati Uniti, dove l’istituto del divorzio ha una storia più lunga della nostra, e che hanno mostrato come spesso, nei casi in cui ci si risposa, la scelta dei nuovi partner ricalca, per caratteristiche psicologiche, quella dei vecchi.
O i suoi effetti si vedono anche quando nei rapporti di lavoro ci si trova a vivere regolarmente situazioni di forte competizione con i colleghi e di marcata conflittualità con i superiori. Conflittualità che rende rabbiosi perché ci si sente trattati male, o depressi quando si pensa di essere stati tropo aggressivi.
O ancora quando sembra che gli amici siano sempre al di sotto delle nostre aspettative, superficiali e inaffidabili, pieni di difetti, e deludono in continuazione.
O infine quando ci si sente delusi anche dai figli. Non sono come li vorremmo e sono invece problematici, irritanti, scostanti.
Perfino nel sentire personale ciascuno di noi ha esperienza di quando non si riesce ad evitare di incorrere in azioni, in modi di dire e di pensare che esitano in fatti negativi, sui quali rimuginiamo a lungo, per i quali ci colpevolizziamo. Ci sforziamo di non farli accadere più, cerchiamo di prendere delle precauzioni, ma si ripropongono automaticamente.
Ci si accorge dei suoi effetti, ho scritto, ma in realtà chi li vive non se ne accorge.
Proviamo a capire. Nel 1920 Freud scrive “Al di là del principio di piacere”. Era da poco terminata la prima guerra mondiale, la Grande Guerra, e Freud si era trovato ad osservare molti pazienti che avevano sviluppato una nevrosi traumatica di guerra. Una delle caratteristiche di questi nevrotici era quella di risognare continuamente la situazione che li aveva traumatizzati.
Freud notò come questo fatto contrastasse fortemente con la sua convinzione che i sogni siano appagamenti di desideri. Inoltre come poteva spiegarsi il fatto così singolare che una scena traumatica e dolorosa invece di essere evitata si ripresentasse frequentemente?
In quello stesso periodo Freud ebbe l’opportunità di stare per qualche tempo in compagnia di un suo nipotino di circa un anno e mezzo. Il bambino aveva l’abitudine a volte di scagliare oggetti lontano da sé e lanciare nel contempo un grido caratteristico, una specie di oh-oh-oh. Un’altra volta Freud notò che il bimbo si posizionava davanti a uno specchio che arrivava quasi fino a terra, poi si accoccolava sul pavimento fino a sparire dallo specchio e poi riappariva tutto compiaciuto. E questo per molte volte.
In un’altra occasione il bimbo aveva un rocchetto legato con un filo. Scagliava il rocchetto oltre il bordo del letto fino a sparlo scomparire dalla vista lanciando il suo caratteristico oh-oh-oh. Poi tirava il filo, il rocchetto riappariva e il bambino allora gridava “da” che in tedesco significa “qui”. Anche questo gioco venne ripetuto molte volte. Cosa significava? Una mattina la madre del bimbo si era preparata per uscire, quando venne a salutarlo il bimbo disse “ mamma oh-oh-oh”. Allora Freud finalmente capì: l’oh-oh-oh stava per la parola “fort” che in tedesco significa “via”. Quindi sia nel gioco del rocchetto che in quello dello specchio il bambino rappresentava una sparizione ed un successivo ritorno, un “ fort-da” che aveva la funzione di rassicurarlo sul fatto che la mamma sarebbe tornata. Ma perché ripetere questa scena che procurava certo il piacere del ritorno, ma anche l’ansia dell’assenza e quindi di nuovo il dolore? Freud collegò il comportamento del bambino al sogno dei traumatizzati in guerra. Noi sappiamo che la paura, l’ansia (o l’angoscia come si dice in tedesco con lo stesso termine “angst” ) sono segnali di preparazione al pericolo, mettono l’organismo in all’erta. Ma nel caso delle nevrosi traumatiche è come se questo allarme fosse mancato, come se l’ansia avesse fallito il suo compito di segnale e non avesse adeguatamente preparato l’organismo a respingere un quantitativo di eccitamento, di qualunque tipo fosse, che l’organismo non riuscì a gestire. Da questo dipese il trauma. Lo scopo del sogno, nel riproporre incessantemente la situazione traumatica, corrispondeva allora al tentativo di proteggere retrospettivamente il sognatore con un messaggio del tipo: “vedrai, questa volta il segnale d’allarme funzionerà, questa volta ti proteggerà”, come se un controllo a posteriori potesse funzionare in ogni caso come un tentativo di guarigione.
E qual è il filo che unisce queste considerazioni al bambino?
Il bimbo con il suo scagliare gli oggetti, o col gioco del rocchetto, non rivive solo un fatto ma, come fa il sogno, lo rievoca e lo reintepreta. Lanciare lontano gli oggetti è come allontanare qualcuno da sé, allontanare la madre. In questo modo non è più lui che subisce l’abbandono, ma in una specie di rovesciamento dei ruoli, è lui che lo provoca. “Non sei tu che mi lasci” sembra dire il bimbo, “sono io che ti mando via”. Così egli tenta di controllare l’angoscia ed il dolore dell’abbandono, ed anzi da questo controllo trae anche il piacere della vendetta.
Ma a lungo andare quello che si ottiene con queste ripetizioni è in realtà solo un aumento di sofferenza, perché ciò che si finisce per reiterare non è che una situazione dolorosa, anche se si tenta di controllarla.
Questo è quanto possiamo osservare nei comportamenti di Anna e Diane.
Anche loro cercavano di ottenere il controllo attraverso la ripetizione; il loro comportamento rispondeva all’imperativo: “riprova, questa volta ci riuscirai, questa volta sarai finalmente amata ed apprezzata”. Il fatto di non riuscire (lo scagliare gli oggetti del bimbo in realtà non lo proteggeva dalle uscite della mamma né dal dolore che queste gli procuravano) contribuiva inoltre ad abbassare ulteriormente la loro autostima e a determinare scelte sempre meno dignitose e, anche, frettolose.
In questo la coazione a ripetere è parente strettissima del masochismo, entrambi realizzano oggi un comportamento rispondendo però a fantasmi del passato. Ma anche con una differenza importante: nel caso della coazione è inesistente qualsiasi tipo di piacere, o se una volta c’era stato, si è definitivamente perso.
Come abbiamo visto le manifestazioni della coazione a ripetere possono essere colte e analizzate nella terapia principalmente durante la nevrosi di trasfert. Ci siamo anche resi conto di come essa attenga proprio a quei ricordi che non sono riusciti ad ottenere una ritrascrizione adatta, cioè una trasformazione, perché sono mancate le condizioni affettive e personali che l’avrebbero resa possibile.
“Si ripete invece di ricordare” diceva Freud. Ricordare etimologicamente significa “rimettere nel cuore”, nella coazione a ripetere invece l’aspetto restitutivo, riparativo è mascherato, nascosto anzi viene escluso dalla ripetizione stessa. In tale senso però la coazione a ripetere definisce anche l’asse di un continuo rilancio del gioco che non può esaurirsi perché è mosso da un desiderio inappagato, ed un desiderio inappagato non rinuncia mai a cercare il suo pieno soddisfacimento. Tutte le ripetizioni, tutte le trasformazioni e sostituzioni non potranno sopprimere la sua persistente tensione. Nella ripetitività oltre la sofferenza c’è anche una continua richiesta di cambiamento e di soddisfazione, richiesta che in quella che Freud chiama “ palestra del trasfert”, proprio lì da dove eravamo partiti dunque, può diventare opportunità di cambiamento, possibilità di sviluppo, generatrice di nuovi scenari. Certo la ripetizione da sola non basta, il gioco si consuma nel conflitto e nell’incontro con l’altro diverso da sé, con il terapeuta in questo caso, ma senza la ripetizione non ci sarebbe gioco né possibilità di cambiamento.
Proprio alla coazione a ripetere, al suo far procedere incespicando, si attagliano i versi di Friedrich Rückert che Freud cita al termine di “Al di la del principio del piacere” e che recitano: “ciò che non si può raggiungere a volo, occorre raggiungerlo zoppicando. La Scrittura dice che zoppicare non è una colpa”.



