Il tema che affronteremo oggi riguarda i disturbi psichici certamente più diffusi.
Dopo la presentazione dei vari quadri sintomatici, affronteremo il problema secondo una prospettiva che si differenzia da quanto si è soliti pensare in termini di malattia e di cura, ma che è profondamente radicata all’interno della tradizione psicoanalitica..
Rivediamo brevemente il concetto di ansia. Come è noto essa è la risposta fisiologica dell’organismo ad un pericolo. L’animale che sta brucando curvo nella savana e si solleva di scatto per mettersi in ascolto del fruscio che l’ha messo in allarme o il cagnolino che ad un rumore drizza improvvisamente le orecchie e rimane tutto teso, sono appunto manifestazioni di ciò. L’ansia è un campanello d’allarme che è di grande aiuto in senso filogenetico per la salvaguardia dell’individuo e della specie, perché ponendo l’organismo in uno stato di allerta, lo prepara all’attacco o alla fuga nella maniera adeguata. Si differenzia dalla paura per il tipo di conoscenza che si ha del pericolo: la paura è la risposta ad un pericolo conosciuto, l’ansia lo è a quello sconosciuto.
Negli esseri umani l’ansia si manifesta anche come risposta ad uno stimolo interno, ed è qui che cade il discrimine tra ansia fisiologica e patologica. Se lo stimolo interno diviene troppo pressante e continuo, l’individuo comincia a vivere uno stato di ansia persistente che a lungo andare, se non si trova un modo per ridurre la pressione, provocherà uno dei disturbi che ora andremo ad elencare.
Il DSM, il manuale statistico dei disturbi psichici più usato nella diagnostica, ne individua sei tipi principali: il disturbo post-traumatico da stress e il disturbo acuto da stress, il disturbo d’ansia generalizzato, il disturbo ossessivo compulsivo, le fobie, e il disturbo da attacchi di panico.
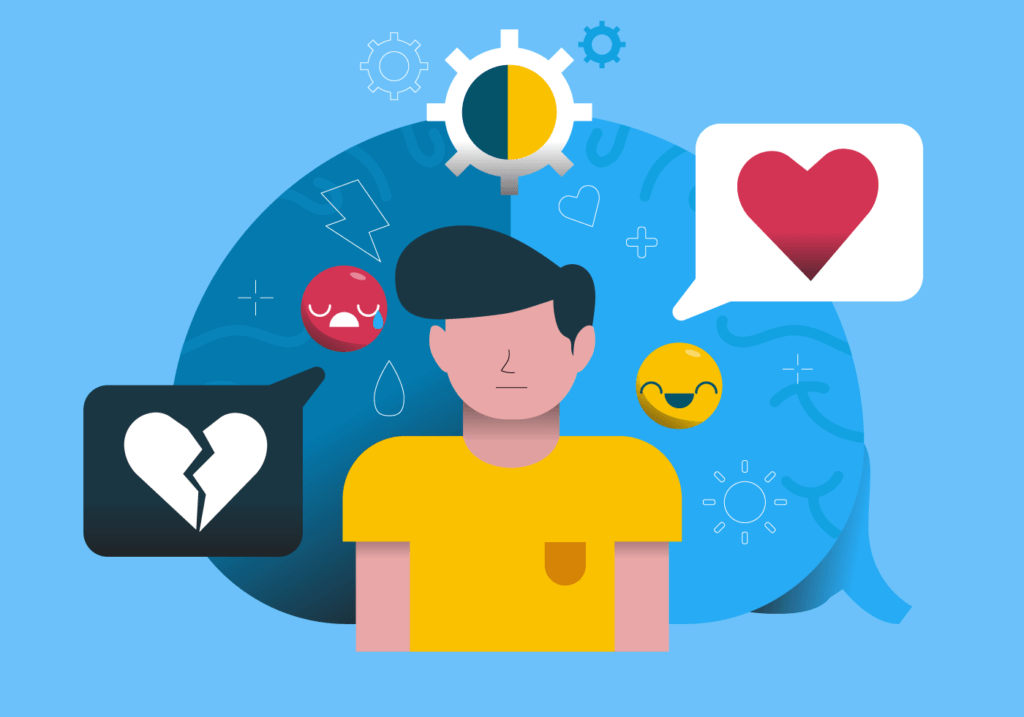
Il disturbo post-traumatico da stress
Ciò che differenzia il disturbo post-traumatico da stress da quello acuto è la durata dei sintomi (che nel caso del disturbo acuto raramente vanno oltre il mese mentre nell’altro durano nel tempo), e la presenza in quello acuto di fenomeni dissociativi quali l’amnesia dissociativa, la depersonalizzazione e la derealizzazione. L’amnesia dissociativa è caratterizzata dall’ incapacità di ricordare, oltre l’episodio traumatico, anche altri dati personali importanti. La derealizzazione consiste nel provare un forte senso di distacco dalla realtà, mentre nella depersonalizzazione si prova un senso di estraneità da se stessi, come se la mente si trovasse al di fuori del proprio corpo e ci si potesse osservare. Tutte queste sensazioni rappresentano un tentativo di distaccarsi emotivamente dall’evento traumatico.
Già Freud si era occupato del disturbo post-traumatico con i reduci della prima guerra mondiale. Egli aveva osservato che i reduci continuavano a sognare ripetutamente l’evento traumatico e questo contrastava con le sue osservazioni precedenti che l’avevano convinto che i sogni rappresentano regolarmente la soddisfazione di un desiderio. Tentò di capire perché la psiche si infliggesse invece la sofferenza così penosa di risognare un evento tanto doloroso e giunse alla conclusione che il ripresentarsi del sogno rappresentava un tentativo di riuscire finalmente a dominare un evento che era stato nella realtà totalmente imprevedibile e incontrollabile. Come se ogni volta il sogno dicesse: “dai, riproviamoci, stavolta ce la faremo” rimanendo invece ogni volta sconfitto.
Anche secondo il DSM l’incubo notturno che richiama l’evento traumatico è uno degli indicatori diagnostici più sicuri del disturbo da stress. In epoca recente è stato studiato con maggior attenzione nel mondo anglosassone, visto che sono stati proprio i paesi anglosassoni ad aver avuto più problemi con i reduci. Film come “Il cacciatore”, ambientato nella in Vietnam, o le notizie sui ripetuti suicidi tra i soldati reduci dall’ Iraq, hanno dato al mondo intero la misura dei disagi sofferti da coloro che hanno subito dei traumi in guerra.
Naturalmente non solo in guerra si può restare vittima di episodi traumatici. Tali disturbi può manifestarli infatti chi ha subito una violenza o uno stupro o anche chi ha assistito direttamente ad eventi che hanno causato la morte o gravi lesioni fisiche ad altre persone.
Nel disturbo da stress la persona vive un innalzamento notevole del proprio livello di ansia ed un abbassamento della soglia della rabbia e dell’irritabilità; di conseguenza il funzionamento sociale e lavorativo risultano spesso notevolmente compromessi, ed i rapporti familiari ne sono così influenzati che sono stati riportati episodi esplosivi di violenza tra le mura domestiche.
Anche a livello fisiologico si riscontrano numerose alterazioni: da quella dei ritmi del sonno alla difficoltà a concentrarsi, dalle esagerate risposte di allarme ad una dolorabilità generale che investe principalmente la testa e l’apparato gastro-intestinale.
Sembra che alle persone non riesca di integrare l’evento traumatico all’interno dell’esperienza di vita precedente: rimane un corpo estraneo, inassimilabile, ma nel contempo molto vicino, intimo e toccante.
Se le cause scatenanti vanno senz’altro ricercate proprio nell’evento traumatico che è esterno ed estraneo alla persona, è pur vero però che molte persone che si ritrovano a vivere esperienze traumatiche non sviluppano il disturbo. Infatti uno studio del 1996 ha evidenziato che solo il 25% delle persone che avevano subito un evento traumatico lo aveva in seguito manifestato. L’evento traumatico non può essere quindi l’unica causa e si sta cercando di individuare quali altri fattori contribuiscano o quali fattori distinguano gli individui che in seguito a un grave trauma manifestano il disturbo post-traumatico da stress da quelli che non lo manifestano.
Il disturbo d’ansia generalizzato
Coloro che presentano il disturbo d’ansia generalizzato, invece, sono preda di una preoccupazione continua spesso riguardante cose di piccola entità.
Se dovessimo individuarne il tratto distintivo dovremmo proprio indicare una sorta di allerta cronica, incontrollabile. Spesso la preoccupazione può riguardare i familiari, ed in questi casi le persone sono costantemente ossessionate e terrorizzate dal fatto che ad un genitore, o più spesso al figlio, possa capitare qualche incidente. Sono inoltre frequentemente invase anche da molti sintomi somatici come sudorazione, vampate di calore, palpitazioni cardiache, nausea, diarrea e bisogno di urinare frequentemente. A ciò si aggiungono spesso dolori alle articolazioni e ai muscoli, disturbi gastro-intestinali (che accompagnano quasi sempre i disturbi d’ansia) e una sorta di stanchezza cronica che si coniuga con la difficoltà di rilassarsi e riposarsi e di avere un sonno regolare. Le persone si lamentano anche dell’incapacità a concentrarsi e a ricordare, come conseguenza inevitabile dello stato di tensione costante che vivono in maniera involontaria e del quale sembrano quasi non rendersi conto.
Nel disturbo d’ansia generalizzata si riscontrano inoltre sintomi che si trovano associati più stabilmente ad altri quadri morbosi quali un’attenzione esagerata per la pulizia e l’ordine, varie preoccupazioni ipocondriache, difficoltà a stare nei luoghi angusti o al contrario nei grandi spazi aperti, e perfino veri e propri attacchi di panico. La comorbilità ricorre anche negli altri disturbi d’ansia, ma in questo caso è più marcata.
Spesso la persona imputa l’insorgenza del disturbo alla contemporanea presenza di un evento stressante, una circostanza che il più delle volte rappresenta però solo l’evento scatenante. L’anamnesi ne rivela infatti frequentemente la presenza già durante l’adolescenza ed anzi molti pazienti riferiscono di averne sofferto fin dall’infanzia.
Anche se negli ultimi tempi il disturbo sembra riguardare sempre più gli uomini, sono le donne ad esserne colpite più frequentemente, con un rapporto di 1 a 2.
Giovanni ha 37 anni quando lo vedo per il primo appuntamento. Mi consulta perché sono oramai due anni che non riesce più ad uscire di casa da solo. E’ questo che mi dice appena arrivato, oltre al fatto di sentirsi molto ansioso e di esserlo sempre stato. Non è sposato e vive con la madre, il padre è morto d’infarto qualche anno prima. Ha una sorella più piccola di tre anni che vive al piano di sopra che non ha figli ed il cui marito lavora a Roma e torna solo nel fine settimana. E’ solo con lei che ancora riesce ad uscire per fare la spesa, ma sempre in maniera frettolosa: solo tra le mura domestiche si sente al sicuro.
Giovanni è impiegato nel Comune del suo paese in un lavoro amministrativo di non grande difficoltà, che svolge con impegno e dedizione. All’ufficio riesce ad andare da solo, lavora nella sua stanza e ne esce se proprio ci è costretto. Vive con la tensione costante che qualcuno lo possa cercare o che gli vengano a chiedere delle informazioni persone che non conosce.
Ha paura che i suoi problemi potrebbero impedirgli prima o poi anche di andare a lavorare. Fuori dall’ufficio non ha praticamente vita sociale.
Da molti anni convive con un cronico dolore di stomaco e si lamenta anche del fatto di non riuscire a tenere puntigliosamente l’ordine in casa. E’ questo l’unico motivo di scontro con la madre che invece, a suo dire, per tale aspetto lascia molto a desiderare.
Dal quadro che Giovanni mi presenta emerge l’immagine di una di una famiglia ripiegata su se stessa che nel corso degli anni non ha fatto altro che chiudersi sempre più. La madre non esce quasi più di casa. E’ una donna che lui descrive come ansiosa da sempre e spesso malata. Ricorda ancora con dolore i mal di testa di lei: si chiudeva nella sua stanza ed era capace di non uscirne per tutto il giorno. Lui si sentiva disperato in quei momenti, disperato, solo e impotente. E anche molto arrabbiato.
Il padre lavorava la campagna e tornava quasi sempre a sera. Ogni tanto, raramente, tardava, si fermava con gli amici a fare due chiacchiere e bere un bicchiere. Qualche volta ne beveva qualcuno in più e tornava a casa più tardi e un po’ alticcio. Allora scoppiavano liti furibonde, la madre aveva delle vere e proprie crisi isteriche e Giovanni e la sorella assistevano impauriti alla scena parteggiando sì per la madre, ma senza capire bene cosa stesse succedendo. La madre li tormentava nei giorni successivi con la paura che il padre potesse rifarlo.
Giovanni non guida, la madre gli ha chiesto di non prendere la patente per il terrore che potesse accadergli qualcosa. Per lo stesso motivo né lui né la sorella sono mai potuti andare ad una gita scolastica. La sorella si è sposata giovanissima, a 18 anni, e lui si è sentito abbandonato, anche se ha compreso che lo ha fatto proprio per uscire di casa, infatti non è contenta del proprio matrimonio. Anche lui dice che avrebbe voluto sposarsi, farsi una famiglia, ma non gli si è mai presentata un’occasione: non ha mai avuto una ragazza e neppure un’amicizia duratura. Sin da bambino a scuola se ne stava in disparte, spesso aveva mal di testa e per due volte è anche svenuto. Crescendo le cose non sono cambiate. A casa studiava, guardava molto la televisione e scriveva poesie che nessuno ha mai letto. Solo dopo circa due anni di terapia me ne ha portata qualcuna da leggere, quando ormai non ne scriveva più. Continua a dirsi molto legato alla sorella e alla madre, e anche se si rende conto che tanti dei problemi che lo fanno soffrire sono in qualche modo un’eredità di quest’ultima, non gliene fa una colpa. Arrivando in terapia si diceva rassegnato al suo stato, avrebbe solo desiderato soffrire meno e non provare tanta ansia. Poi si è reso conto che è troppo chiedere di cambiare, purché tutto resti com’è.
Di recente ha fatto un sogno in cui si trovava lontano da casa. Preso da grande angoscia, inizia a correre verso casa, ma prendono ad inseguirlo dei cani. Mentre scappa sempre più impaurito, vede una figura seria vestita di nero. Le si avvicina, chiede aiuto, ma questa gli risponde bruscamente che lo sa da solo che non c’è nulla da temere. Intanto è stato circondato dai cani, ma invece di riprendere a correre comincia a interessarsi a loro, e anche se un cane grande gli abbaia furiosamente contro, non ne ha più terrore come prima e contemporaneamente sente attenuarsi l’angoscia per la lontananza da casa.
L’analisi del sogno ci ha mostrato che la figura rigida vestita di nero rappresenta la sua parte razionale, quella che non ha comprensione per le sue difficoltà e lo incita solo con la durezza. I cani rappresentano invece la sua parte più istintuale, aggressiva ed emotiva. Ed è lo spostamento di attenzione dalle sue paure a questa parte di sé, che provoca la diminuzione dell’ansia.
Il disturbo ossessivo-compulsivo
Approfondiremo in seguito questo aspetto, per ora proseguiamo parlando di un altro disturbo d’ansia, quello ossessivo-compulsivo, che è caratterizzato dalla presenza di pensieri o atti incontrollabili che la persona è spinta irresistibilmente a ripetere.
Ne “L’uomo dei topi: osservazioni su un caso di nevrosi ossessiva” del 1908, Freud ci ha offerto un resoconto alla sua maniera di questo disturbo. Il caso dell’avvocato trentenne che era ossessionato dalla paura che a suo padre potesse essere inflitta la tortura orientale dei topi, che vengono fatti penetrare nell’ano del condannato, è ormai molto conosciuto.
Freud ha messo in evidenza l’ambivalenza che caratterizza questo disturbo: l’uomo dei topi era molto legato al padre, conservava tuttavia nei suoi confronti un odio inconscio al seguito di quando era stato picchiato da lui da bambino, perché aveva morso la governante. Non essendo moralmente ammissibile l’espressione dell’odio nei confronti del padre, il paziente aveva sviluppato l’ossessione che al padre potesse accadere un supplizio del genere, ma Freud ha mostrato come nella paura del supplizio fosse espressa sia l’aggressività verso il genitore che la tenerezza provata verso di lui. C’è l’ambivalenza alla base dell’ossessione dell’uomo dei topi, l’ambivalenza tra due sentimenti opposti che generano un conflitto, e che non è possibile risolvere finché i sentimenti non vengono portati alla luce.
Dai tempi di Freud il disturbo ha mutato nome, oggi è denominato disturbo ossessivo-compulsivo e contempla appunto ossessioni e compulsioni. Il solito DSM definisce le ossessioni come pensieri, impulsi, o immagini a carattere invasivo e ripetitivo, che si presentano non voluti alla mente, e appaiono irrazionali e incontrollabili all’individuo che li subisce; le compulsioni come un comportamento ripetitivo o un’azione mentale che la persona si sente costretta ad eseguire per ridurre il disagio causato dai pensieri ossessivi o per scongiurare il verificarsi di una qualche calamità. Sia le ossessioni che le compulsioni conducono alla ripetizione di pensieri, gesti e comportamenti che hanno la funzione di tenere costantemente sotto controllo l’ambiente circostante, come strategia atta ad allontanare da sé un impulso ritenuto inaccettabile, come faceva con la propria aggressività verso il padre il paziente di Freud.
Quello che più teme chi soffre di tale disturbo è l’imprevisto, l’inaspettato, il dubbio soprattutto, proprio perché in questi casi rischia di saltare il meccanismo di controllo.
Le ossessioni possono diventare così invasive e frequenti da limitare grandemente il normale funzionamento psichico. Le più comuni riguardano il timore di essere contaminati dallo sporco o dalle infezioni, oppure la paura ipocondriaca di disfunzioni fisiche dietro alle quali si teme si celi un disturbo fatale.
La paura delle contaminazioni o delle malattie può estendersi anche alle persone care, rendendo ancora più vasto l’universo da controllare e più arduo e penoso il compito di preservazione.
Le compulsioni più comuni hanno a che fare con la pulizia, con l’ordine e con il tener lontani i pericoli. La pulizia si raggiunge solo con lavaggi ripetuti e sfinenti, evitando qualunque contatto con ciò che toccano gli altri: maniglie, interruttori, sedie, tavoli, oggetti di uso comune, per l’ossessivo non rappresentano altro che una riserva di batteri che occorre assolutamente evitare e così, penosamente vergognandosene, ricorre a tutta una serie di stratagemmi per aprire la maniglia o per accendere la luce stando attento a non contaminarsi e nel contempo a non farsi notare dagli altri. Molto spesso il mantenimento dell’ordine o le pratiche protettive rispetto ai pericoli temuti, vengono ottenuti solo al prezzo di complicati cerimoniali che possono durare anche molte ore, a volte occupare la maggior parte della giornata, senza che possano essere interrotti, anzi se qualcosa interferisce con il cerimoniale, esso deve essere ricominciato daccapo.
Le persone affette da questo disturbo si lamentano della ripetitività e della incoercibilità dei loro gesti e delle loro pratiche: sanno benissimo che il gas o la porta sono chiusi, ma non possono esimersi dal tornare ancora una volta indietro a controllarli. Poichè se non sono sicuri di averlo fatto bene, si scatena un’ansia tale da impedire loro di fare qualcosa d’altro: da quella omissione potrebbero derivare infatti catastrofi (se non hanno chiuso bene il gas potrebbe esplodere il palazzo, se lasciano la porta aperta potrebbero entrare dei malfattori che rubano e uccidono) e allora sono costretti a ricominciare da capo.
A volte le compulsioni assumono la caratteristica di atti ripetitivi, che sembrano non avere alcun altro scopo se non quello di proteggere magicamente da pericoli che potrebbero presentarsi se il soggetto non si attenesse a tali pratiche, come il contare ripetutamente le fessure delle mattonelle, pensare ad una serie preordinata di numeri, ripetere una serie di parole in una certa sequenza, etc. Il disturbo ossessivo-compulsivo di solito insorge alla fine dell’adolescenza spesso in seguito a qualche evento stressante in famiglia, a difficoltà sul lavoro o in seguito a degli eventi dolorosi come una disgrazia o un lutto. Riguarda più gli uomini che le donne ed è frequentemente associato ad altri disturbi d’ansia, in particolare alle preoccupazioni ipocondriache ed alle fobie, tanto che a volte è difficile distinguere le une dall’altro.
A volte nel corso della vita può accadere di sviluppare per un certo periodo fugaci esperienze di tipo ossessivo-compulsivo, ma esse si risolvono da sole in genere dopo un breve periodo. Per chi è invece affetto veramente da tale disturbo, e non è difficile arrivare alla diagnosi differenziale, le ossessioni e le compulsioni, oltre a rappresentare un grave disagio psicologico, possono diventare di tale intensità e frequenza da interferire pesantemente con le normali attività quotidiane.
Anche le relazioni familiari ed interpersonali risentono pesantemente della situazione. La incoercibilità delle compulsioni e la loro ripetitività genera negli altri preoccupazione ed apprensione e l’attenzione continua richiesta dalle ossessioni, provoca un distacco dagli altri, un isolamento che a lungo andare deteriora i rapporti pesantemente.
Le fobie
Le fobie invece, che possono essere specifiche e sociali, vengono definite come un comportamento di evitamento sovradimensionato rispetto al pericolo rappresentato da un oggetto o da una situazione specifici. L’individuo ne riconosce l’irragionevolezza, ma non può esimersi dal temerli. Un’eventuale esposizione forzata ad essi produce un’ansia intollerabile.
Le fobie specifiche possono riguardare qualunque oggetto o situazione, ne sono state individuate centinaia ed ognuna col proprio nome. Le più ricorrenti sono però rappresentate:
dalle fobie degli animali: dei serpenti, dei topi, dei ragni o del cavallo, come era per il piccolo Hans di cui parlammo qualche seminario fa;
dalle fobie delle infezioni: del sangue, delle urine, dello sperma. Legate particolarmente ai liquidi corporei spesso sono associate alla fobia per lo sporco;
dalle fobie cosiddette situazionali: dei luoghi aperti e dei luoghi chiusi, dei tunnel e degli ascensori, dei viadotti e delle piazze, dei cinema e dei supermercati, di volare e di guidare.
La fobia sociale invece, anch’essa in notevole aumento, si caratterizza come una paura irrazionale e persistente collegata alla presenza di altre persone. Questa condizione può divenire estremamente limitante, perchè chi ne soffre cerca di evitare i momenti in cui potrebbe trovarsi ad essere oggetto di attenzione o di valutazione da parte di altri. Se per qualche motivo non si può evitare la situazione temuta, e la persona si sente costretta a sopportarla senza avere una via di fuga, può scatenarsi un’ansia talmente intollerabile da esitare in un attacco di panico o in uno svenimento.
L’esordio delle fobie sociali è spesso localizzato durante l’adolescenza, anche se non è raro che queste paure si manifestino tra i bambini.
Ed infatti fin da bambino Marco ha avuto difficoltà a relazionarsi. Tendeva a rimanere in casa a guardare la televisione, piuttosto che andare a giocare con gli altri. I genitori lavoravano entrambi in una fabbrica e tornavano a casa verso le sei del pomeriggio. Marco ben presto si accorse che ai genitori dispiaceva che non fosse uscito, visto che lo spronavano a farlo al loro rientro. Capiva che erano preoccupati dal fatto che lui fosse così diverso dagli altri per questo aspetto e iniziò a dire delle bugie, a raccontare che era stato in un posto o nell’altro dopo aver pranzato dalla zia. Aveva anche imparato a farsi trovare a fare i compiti al loro ritorno, per giustificare l’uscita pomeridiana, e a vedere la televisione nel primo pomeriggio, anche se questo lo faceva rinunciare a vedere un programma che facevano più tardi e che gli piaceva tanto. Lui ebbe sempre il sospetto che i genitori avessero intuito qualcosa, ma non facevano troppe domande: era evidentemente doloroso anche per loro svelare la sua bugia e così un po’ ci credevano e un po’ volevano crederci. La difficoltà maggiore nasceva durante i fine settimana o nei periodi di vacanza, quando il gioco infrasettimanale non reggeva più. Allora aveva preso l’abitudine di recarsi in un angolo del portico di una casa che era stata abbandonata (Marco viveva in un paesino dei dintorni dove forte era stata l’emigrazione) e lì aspettava un tempo che gli paresse congruo a giustificare un’uscita.
A poco a poco aveva ritenuto una grave colpa il fatto di non essere capace di uscire. In casa stava bene, aveva tutte le sue cose, ma non poteva godersi i suoi spazi, non poteva rilassarsi al pensiero che stava facendo qualcosa di sbagliato perché non usciva. Ricordo il sollievo che provò quando durante la terapia gli dissi che non era obbligato ad uscire, se non voleva. Certo sapeva bene che così facendo la vita scorreva fuori e lontano da lui, ma per il momento le cose non potevano andare che così. Inoltre il disturbo era particolarmente accentuato proprio nel paese in cui viveva ( tutte le fobie hanno un luogo privilegiato in cui esplicano la massima potenza). Quando frequentava le superiori ad Avezzano viveva una vita scolastica abbastanza normale, stava con gli altri con serenità e, pur non essendo un chiacchierone, riusciva a relazionarsi sia a scuola che fuori partecipando a gite o altro. Tornato al paese riprendeva invece il comportamento solito.
E fu infatti la circostanza di aver terminato l’Università, a spingerlo a cercare aiuto. L’aveva frequentata a Perugia, non risentendo particolarmente delle sue limitazioni, ma ora che si era laureato ed era tornato a casa nell’attesa di trovare lavoro, i problemi erano ricominciati come nel passato e quando era stato costretto a uscire aveva sperimentato per la prima volta degli attacchi di panico. Anzi una volta era stato costretto a fuggire lasciando gli amici in piazza senza una spiegazione, poi era stato pronto ad accusare della fuga un improvviso mal di pancia.
Il disturbo da attacchi di panico
Per ultimo ho lasciato il disturbo da attacchi di panico, perché è grazie ad esso che potremo proseguire il discorso che ho accennato all’inizio.
Il disturbo da attacchi di panico consiste in un attacco improvviso, imprevedibile e inspiegabile che comprende un elevato numero di sintomi: difficoltà di respiro e sensazioni di soffocamento, palpitazioni, nausea, dolore al petto, tremori, capogiri, sudorazione intensa, sensazione di paura che può arrivare al terrore di svenire, di diventare pazzi o addirittura di morire. Inoltre, come nel disturbo acuto da stress, durante l’attacco si possono avvertire sensazioni di depersonalizzazione e di derealizzazione. Naturalmente è raro che questi sintomi si possano sperimentare tutti insieme durante un unico attacco, ne sono presenti comunque un buon numero.
L’insorgenza degli attacchi può variare da persona a persona sia rispetto all’età che al modo di manifestarsi. Si può dire che non esiste un’età che metta al sicuro: sono stati riferiti casi del primo attacco nei bambini, negli adolescenti, negli adulti e perfino in età ancora più avanzata.
Può accadere che si sperimenti un attacco una volta sola e che poi non si manifesti più per molti anni, o che si manifesti in maniera saltuaria e molto poco frequente, o magari una volta alla settimana, rimanendo sempre più o meno costante. Ma può accadere che gli attacchi si verifichino più volte al giorno e persino di notte, interferendo molto con le normali attività della vita o rendendole addirittura impossibili.
Ma indipendentemente dalla frequenza e dalle situazioni in cui si verifica, quel che è certo è che una volta che l’attacco c’è stato non si dimentica e anzi spesso si inizia a vivere con la paura che la cosa possa ripetersi. E’ proprio la forte ansia anticipatoria presente tra un attacco e l’altro che danneggia più degli attacchi veri e propri.
Infatti gli attacchi generalmente durano solo qualche minuto, e anche se a chi li subisce sembra un tempo interminabile, raramente si protraggono per più tempo. A volte sono associati a situazioni specifiche, come abbiamo visto prima nel caso di Marco quando si trovava fuori casa, ed allora diventano certo più prevedibili, altre volte sembra che non abbiano alcuna causa scatenante e paiono del tutto ingiustificati.
Inoltre in circa il 50% dei casi l’attacco di panico può risultare complicato dalla presenza dell’agorafobia, la paura degli spazi aperti, che ha per oggetto i luoghi pubblici e frequentati dai quali potrebbe essere difficoltoso allontanarsi o nei quali potrebbe non essere disponibile un aiuto nel caso che l’individuo stia male. Ciò comporta la paura di andare nei negozi (specialmente nei supermercati, perché più affollati) o nei cinema, la paura di ritrovarsi in mezzo alla folla, la paura di viaggiare e di lasciare la propria casa. Per chi soffre di attacchi di panico e di agorafobia la casa rappresenta il più delle volte l’unico luogo in cui sentirsi al sicuro ed infatti a volte il disturbo acquista un’ ulteriore condizione invalidante quando il soggetto inizia a sentirsi insicuro anche in casa e ha bisogno di non essere lasciato solo per stare più tranquillo.
Spesso Flavia si sente angosciata. Fino a qualche mese fa l’angoscia si trasformava quasi sempre in un attacco di panico, ora invece sente “solo” angoscia. La terapia è iniziata da circa sei mesi, continua a ripetere che non c’è alcun motivo perchè oggi, ad esempio, provi angoscia, anche se mi dice, scherzando, che ormai ha imparato che lei il motivo non lo conosce, ma c’è. Ed infatti spesso le sedute si svolgono procedendo ad una sorta di disvelamento, che mostra regolarmente come alla base dell’angoscia ci sia stato un sentimento di delusione, di fallimento, di scacco alla propria autostima: un compagno di studi le ha risposto male, la cara amica del cuore, mentre passeggiavano, rideva e parlava quasi esclusivamente con la nuova arrivata, il fidanzato ha tardato a chiamarla o è arrivato tardi all’appuntamento senza avvisarla, la madre continua a farle intendere che il fratello è più in gamba di lei: all’Università ha fatto più esami ed è di 2 anni più piccolo.
Quando Flavia riesce a collegare lo stato d’animo attuale con uno degli avvenimenti elencati, l’angoscia tende a sciogliersi e si chiede perché non ha pensato da sola a fare il collegamento.
Per lei, come per tutte le altre persone di cui abbiamo parlato, i suoi sintomi sono assurdi e senza senso e l’unica cosa che vorrebbe è che sparissero.
Infatti il disturbo psichico, e in maniera ancora più marcata la malattia mentale, hanno sempre avuto una doppia chiave di lettura: quella di stampo più eminentemente medico e clinico, che definisce il paziente come affetto da tale o talaltro quadro morboso caratterizzato da una certa sintomatologia, etc., ed una di carattere più sociale, che ha a che fare con il pregiudizio e con lo stigma. Come se chi soffre di un disturbo psichico assommi su di sé delle carenze che lo rendono diverso dagli altri. Certamente tale pregiudizio risente delle difficoltà di cura che aveva in passato la malattia mentale, ma più ancora credo sia importante proprio il carattere di stranezza e di incoercibilità che hanno i sintomi conseguenti ad un disagio psicologico. Infatti la stessa cosa pensa di sé chi questi disagi mostra: avvertire delle spinte incontrollabili, presentare dei sintomi all’apparenza così incongrui, credere di avere un qualche difetto nella volontà per la difficoltà di vincere tali manifestazioni, induce la persona a tenere celato il disturbo, a vergognarsene, a nasconderlo persino alle persone più care, nella convinzione di essere posseduti da qualcosa di unico, che è solo loro e tremendamente disdicevole.
Anni fa una psicologa americana pubblicò un libro sul disturbo ossessivo- compulsivo dal titolo “Il ragazzo che si lavava troppo le mani”. Qualche tempo dopo, la stessa psicologa intervenne in un programma televisivo, dicendosi meravigliata del gran numero di persone che l’avevano contattata o le avevano scritto per ringraziarla del suo libro, perché per la prima volta in vita loro, avevano avuto la possibilità di non sentirsi soli con il loro disturbo, avevano potuto sperimentare la condivisione, il diminuire della vergogna che sempre si accompagna al sentire comune. Insomma il “mal comune mezzo gaudio” non credo che sia un detto che va bene solo per gli Italiani….
Ed è infatti con un gran senso di solitudine rispetto al loro disturbo che le persone si rivolgono ai terapeuti. Ormai le riviste sono piene di rubriche “l’esperto risponde”, dove psicologi e psicologhe, rassicurano le molte persone che scrivono loro sull’accresciuta diffusione dei disturbi d’ansia. Eppure quasi sempre i pazienti nei loro primi appuntamenti, chiedono se sono solo loro a soffrire di quel disturbo, se ce ne sono anche altri, se io li ho già curati, se gli altri sono guariti, etc. Certo anche queste domande sono frutto dell’ansia, ma il bisogno di rassicurazione e condivisione, come abbiamo visto prima nell’episodio della psicologa americana, è molto forte nei confronti dei disturbi psichici. La domanda “perché soffro di un disturbo così strano” si presenta incessantemente.
Flavia, come la maggior parte degli altri pazienti, si lamenta perché si sente troppo debole nel dominare le sue dinamiche psicologiche, vorrebbe diventare più forte, per schiacciare quella parte di sè che la fa soffrire. Di fronte alle sue richieste io rispondo che lei non è troppo debole, ma troppo forte. Perché le rispondo così? Scommetto che in questa sala nessuno o molto pochi sarebbero d’accordo con me, quasi tutti sareste d’accordo con Flavia.
E’ a questo punto, allora, che vorrei introdurre la prospettiva di cui parlavo all’inizio.
L’apparente assurdità dei sintomi nevrotici è sempre stato un problema per la medicina. E’ solo con Freud, con la scoperta dell’inconscio, delle leggi che lo regolano e del modo conflittuale con cui si relaziona con la coscienza, che si arriva a trovare un senso ai sintomi nevrotici.
Per Freud l’inconscio non è il luogo dell’irrazionalità e dell’istintualità selvaggia, ma principalmente il luogo dove risiede il nostro desiderio. Ne “L’interpretazioni dei sogni”, in “Psicopatologia della vita quotidiana”, nei “Tre saggi sulla vita sessuale”, in “Introduzione alla psicoanalisi”, probabilmente i testi di Freud più noti, egli ci indica i mille modi in cui il desiderio tende a mostrarsi, in una lotta incessante con la nostra parte vigile e cosciente: nei sogni, nei lapsus, negli atti mancati e nei sintomi nevrotici. La stranezza, l’apparente inspiegabilità di questi fenomeni non è un semplice zoppicamento del linguaggio, un incidente, ma un cortocircuito tra due intenzionalità divergenti: quella inconscia e quella cosciente. Quella inconscia portatrice del desiderio e quella cosciente che vi si oppone. La stranezza del sintomo, come quella del sogno, è il risultato del mascheramento che le forze repressive e censorie della coscienza esercitano sui contenuti dell’inconscio. Per renderli accettabili, essa li rende irriconoscibili. Il sintomo ed il contenuto del sogno rappresentano la formazione di compromesso che permette al desiderio di manifestarsi. Altro che assurdità dei sintomi e dei sogni, è l’unica maniera che ha il desiderio per farsi conoscere!
L’inconscio è per Freud un sapere che agisce come una perturbazione sulla coscienza: le chiede di tener conto delle proprie istanze, di assumere anche ciò che sembra contrastarla. E’ nell’inconscio che si trova la nostra parte più vera.
Il vero Sé, lo chiamerà anni dopo Winnicott.
Freud si rese conto che ciò equivaleva a dire agli uomini che non erano “padroni in casa propria”, che veniva inflitto un duro colpo all’idea che la realtà coincida con la coscienza, con l’Io. Con la psicoanalisi è proprio il concetto di identità che si problematizza. “Credersi un io” affermava Lacan, uno dei più geniali discepoli di Freud, “è la vera follia dell’uomo”.
Il nuovo punto di vista della psicoanalisi consiste nel pensare che la malattia psichica non scaturisca da una fragilità dell’Io, come ritiene una certa psicologia della prestazione e come pensano Flavia, gli altri pazienti che chiedono di diventare più forti, e forse anche voi, ma al contrario, da un suo rafforzamento eccessivo. In questo senso più c’è rafforzamento dell’Io e più c’è sofferenza. Questa prospettiva corregge un certo modo di intendere la malattia psichica, che non si fa discendere da una eccessiva presenza dell’inconscio, ma dalla sua eccessiva assenza. La malattia non è causata dall’inconscio, ma dalla sua negazione. Ci si ammala perché ci si allontana dall’inconscio e ci si irrigidisce nell’identificarsi con i confini sterili del proprio Io. Ed infatti le domande di aiuto che lo psicoanalista riceve possono essere molto diverse, ma sono tutte accomunate dal fatto che il soggetto che le pone non è più sicuro di essere ciò che sino a quel momento pensava di essere. L’esperienza dell’inconscio è un’esperienza di mancanza di padronanza.
La protezione eccessiva del proprio confine identitario, identificato con l’Io e con la razionalità, tende a ribaltarsi nel suo contrario, come è drammaticamente confermato nelle cosiddette malattie autoimmuni, nelle quali una difesa eccessivamente rigida dell’organismo, da parte del suo apparato immunologico, ne può causare paradossalmente la distruzione.
Questa impostazione ha chiaramente delle ripercussioni notevoli sul versante della cura.
Il paziente, come abbiamo detto, non chiede altro che di tornare “com’era prima”, di far scomparire i sintomi prima possibile e di riacquistare la padronanza perduta. Questo per lui vuol dire guarire.
Bisogna insistere, invece, sul valore di segnale dei sintomi, e cercare di comprendere che il sintomo evidenzia un disequilibrio che se viene mascherato, come a volte può accadere per esempio con l’uso di un farmaco o anche effettuando una psicoterapia, diciamo, più “prestazionale”, lo squilibrio rimane. Lo scopo di una psicoanalisi non è quello di una pratica di ortopedia psicologica. Il dispositivo psicoanalitico si mantiene se il paziente viene condotto a toccare il limite del suo sapere, a frequentare i suoi vuoti, i suoi bordi meno conosciuti.
Ad esempio, una remissione rapida di un quadro sintomatico non sarà affatto considerata come una “guarigione”, Anche se si può immaginare quanto il paziente trovi vantaggiosa e gratificante una simile prospettiva, e senza sottovalutare il significato che ciò può avere in termini di diminuzione della sofferenza e di motivazione alla terapia, tuttavia la guarigione è altra cosa.
Già Freud si era reso conto di questo, quando nel 1914 scrive che non si deve avere il bisogno di alleviare la sofferenza del paziente troppo rapidamente, perché “il rischio che corriamo altrimenti, è di non ottenere mai più un miglioramento, se non modesto e transitorio”.
Freud si espresse in questo modo mentre stava occupandosi del concetto di astinenza subito dopo la scoperta del transfert. Scrisse infatti inoltre che “la tecnica psicoanalitica fa obbligo al medico di rifiutare alla paziente bisognosa d’amore il soddisfacimento richiesto”. La frase non va letta solo in senso morale, ma all’interno dell’elaborazione del concetto di astinenza : se l’analista soddisfa rapidamente il bisogno d’amore, rischia di eliminare per sempre la possibilità di comprendere cosa quell’espressione può significare per la paziente, al di là della richiesta immediata. Lo stesso che può accadere con una remissione troppo rapida dei sintomi, quindi, tanto che in questi casi si usa l’espressione “fuga nella salute”, a significare un miglioramento tanto improvviso quanto temporaneo .
Col tempo il concetto di astinenza è diventato sempre più centrale nella tecnica psicoanalitica, investendo in modo più complesso ogni tipo di inferenza che l’analista può avere sul paziente e che possa rappresentare un ostacolo al libero flusso dei pensieri e delle parole, interferendo con l’avvicinamento all’inconscio del soggetto.
In questa direzione va letto il rifiuto di dare consigli da parte dell’analista. Sempre senza troppa rigidità (insomma un’analisi è un luogo molto più libero di quanto può apparire da queste mie parole), un’analista dovrebbe accogliere le manifestazioni dell’inconscio del paziente, non fornire indottrinamenti o esplicitazioni del suo sapere. Bion raccomandava di accostarsi alla seduta senza memoria e senza desiderio, con ciò volendo significare di lasciare il massimo spazio alle possibilità espressive.
Anche la non risposta, o il tante volte irriso silenzio dell’analista non sono misure sadiche volte a tiranneggiare il paziente, ma gli unici movimenti autenticamente etici che consentono a una psicoanalisi di svilupparsi. Se invece l’analista si prodigasse ad esibire il suo sapere con spiegazioni e interpretazioni che anticipano la parola del soggetto, o ponendosi come un modello o intervenendo nella realtà, allora egli renderebbe impossibile l’esercizio pieno della parola del paziente, gli renderebbe difficile produrre il suo inconscio.
Insomma, per fare un riferimento personale, quando i pazienti mi rimproverano i miei silenzi, mi dicono che parlo poco, che mi vorrebbero più attivo, non stanno tanto lamentandosi del mio di silenzio, quanto di quello del loro inconscio o della resistenza che avvertono nel manifestarlo. Paradossalmente è di maggior silenzio che hanno bisogno, anche del loro, per ascoltare meglio. Insomma parlare di più, o meglio parlare quando non è necessario, quando ciò che serve è l’ascolto, non rende un buon servizio all’analisi.
Winnicott esalta come virtù fondamentale dell’analista saper operare con la propria ignoranza e afferma che in ogni seduta tende a ”intervenire almeno una volta, ovvero quel tanto che basta per rivelare al paziente che non ha inteso bene”. Ma insomma, senza arrivare alle ascesi di Winnicott, credo che si sia compreso quanto voglio dire.
Ora possiamo tornare a Flavia. L’abbiamo lasciata mentre mi chiedeva di aiutarla a diventare più forte, ed io a dirle che meno forte doveva diventare, non il contrario.
Abbiamo visto prima che l’angoscia è il segnale della distanza dal proprio inconscio, dal proprio desiderio, dal vero Sé. Più il desiderio bussa alle porte della coscienza per manifestarsi e più l’Io si sente minacciato e sviluppa angoscia. Perché però in Flavia l’angoscia si sviluppa quando viene trattata male dall’amica o trascurata dal fidanzato, cosa c’entra questo col desiderio? Si dirà: quando veniamo trattati male o non riconosciuti nel nostro ruolo, sempre soffriamo. E’ vero, e ci arrabbiamo anche, se possiamo ci ribelliamo, gridiamo all’ingiustizia. Proviamo anche ansia o un’altra emozione molto violenta se la nostra rabbia è urlata o agita con il corpo, ma non proviamo l’angoscia paralizzante di Flavia, che spesso si rivolge contro di sé provocandole il dolore fisico o l’attacco di panico. Lei è paralizzata perchè, per esempio col fidanzato, si sente come la preda in trappola, e come fanno spesso le prede per difendersi, si paralizza. Non ha altri strumenti: sente di non poter avere un avvenire senza di lui, non riesce a vedersi da sola, a pensarsi da sola, a immaginare di ricominciare con un’altra persona. E chi la vorrà mai di nuovo, inoltre. Flavia è una bella ragazza, ma ha un’immagine distorta del suo corpo, si vede brutta e insignificante, ed infatti anche la cura di sé lascia molto a desiderare. Non si veste in maniera da mettere in rilievo la sua femminilità, non usa gonna, tacchi, rossetto, porta sempre i capelli legati, etc. Le donne sanno bene cosa intendo dire.
A volte avverte confusamente dentro di sé una spinta che la vorrebbe in una posizione più autonoma e indipendente rispetto alle persone per lei significative (ed infatti i sentimenti che legano Flavia al fidanzato, per quegli aspetti che riguardano l’autonomia e l’indipendenza, non sono dissimili da quelli che prova per i genitori o gli amici), ma il pensiero la spaventa, lo scaccia. Teme che se desse ascolto a questa voce non sarebbe più accettata, ma verrebbe rifiutata e abbandonata. Teme che questa spinta sia l’espressione della parte peggiore di lei, e così, pur di metterla a tacere, accetta, e adotta lei stessa, atteggiamenti che la fanno soffrire e che le sembra di meritare visto che alberga pensieri così negativi, visto che è così cattiva.
Quindi, e questo è un indicatore che rivela molto del modo in cui ci rapportiamo con noi stessi e con gli altri, quando accadono questi fatti, Flavia oltre a soffrire come abbiamo visto, si sente anche regolarmente in colpa.
Perché si sente in colpa se sembra lei la vittima? Credo perché in maniera confusa avverte di star facendo qualcosa che non è in sintonia col suo essere più autentico e la colpa deriva dalla pressione che esercita su se stessa per far sì che le cose rimangano come sono. La spinta che a volte Flavia sente e che reprime, è il suo desiderio che cerca espressione, e così facendo, nel tempo è diventata sempre più inautentica, finché la troppa distanza dal suo vero Sé l’ha fatta ammalare.
Lacan, colui che più di altri ha indagato il desiderio in ambito psicoanalitico, dice che in questi casi “c’è assimilazione passiva alla domanda dell’Altro, c’è delega del proprio desiderio: sarò quello che l’Altro vuole che io sia, per restare amabile ai suoi occhi, per non deludere angosciare o irritare. Cedo sul mio desiderio perché essere amato dall’Altro produce il vantaggio di giustificare la mia esistenza, le dona un senso, la rende necessaria”. Per questo nella vita di un soggetto l’emergere del desiderio comporta sempre un certo effetto di spaesamento, di vertigine, una sensazione di sbandamento. L’emergere del desiderio è in contrasto con tutte le tendenze adattive, interrompe l’immersione del soggetto nel discorso comune, strappa dalla beata e ottusa identificazione conformistica al presunto desiderio degli altri. Perciò il desiderio va combattuto, va tenuto alla larga, lontano dalla nostra consapevolezza
E poiché la spinta del desiderio è inestinguibile, anche la nostra controspinta sarà sempre maggiore.
Così ad un certo punto ci si ritrova come a comprimere l’acqua: più pressione si esercita da una parte, più c’è fuoriuscita da un’altra: un sintomo sempre più incoercibile, l’angoscia sempre più pervasiva. Finché non ci si arrende e si chiede aiuto, magari perché qualcun altro si allei con noi per esercitare più pressione….



